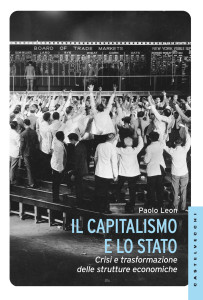A 81 anni è mancato Paolo Leon, tra i fondatori della Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre, economista attento alle trasformazioni del capitalismo, molto attivo nella ricerca e nella politica dove aveva ricoperto vari incarichi istituzionali
Paolo Leon, importante economista italiano, è mancato l’11 giugno, a 81 anni. Era stato tra i fondatori della Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre, ed è stato molto attivo nella ricerca – keynesiano molto critico delle attuali politiche europee – e nella politica – era stato a lungo nel Psi e aveva ricoperto vari incarichi istituzionali. Lo ricordiamo presentando qui alcuni brani del suo libro “Il capitalismo e lo stato” (Castelvecchi, 2014) in cui analizza le trasformazioni dell’economia e della politica alla luce della crisi del 2007.
A parte gli economisti classici (Smith, Ricardo, Marx), non conosco un metodo capace di indagare sulla specifica natura di ogni trasformazione del capitalismo, nonostante gli innumerevoli modelli che cercano, dopo aver abbandonato i classici, di spiegare, mimandolo, il comportamento dell’economia e dei suoi soggetti. Perciò, sono costretto a descrivere le istituzioni economiche del capitalismo nelle due epoche che ho vissuto direttamente: la prima, successiva alle politiche del New Deal, e la seconda, che parte dalle riforme conservatrici del Primo Ministro Thatcher e del Presidente Reagan, tra il 1979 e il 1981, e finisce (?) con la crisi del 2007-08. È impressionante l’espansione planetaria della crescita economica nel capitalismo post-Reagan-Thatcher, quando la netta inferiorità dello Stato rispetto agli interessi dei capitalisti avrebbe dovuto impedirla, se la giudicassimo sulla base delle istituzioni rooseveltiane. Non si possono paragonare periodi storici diversi, ma il confronto fornisce indizi corposi sulle trasformazioni del capitalismo, stilizzandole fortemente e osservandone le evoluzioni. Nel farlo, ho dovuto anche riferirmi alle vicende economiche e ai principali cambiamenti istituzionali dei due periodi; mi auguro che questo saggio non sia giudicato sul metodo storico, ma sulla verosimiglianza dell’ipotesi generale: che ogni capitalismo genera dinamiche al proprio interno che lo trasformano in un capitalismo diverso dal precedente e che tale diversità si vede nel rapporto tra capitalisti e Stato e tra diversi capitalisti. Saranno anche evidenti le differenze tra il capitalismo americano e quello europeo.” (p.15).
“È evidente l’assenza dello Stato nel processo di accumulazione: l’antitrust è inefficace, la banca centrale non vigila sulle imprese finanziarie, l’imposizione fiscale sul patrimonio è frenata dalla concorrenza sui capitali tra diverse economie, non c’è bisogno di politiche economiche per la domanda effettiva perché l’esplosione finanziaria ha effetti economici «reali», la nuova moneta endogena sostituisce la moneta esogena e riduce la sovranità degli Stati. L’enfasi sullo Stato minimo è soltanto l’orpello ideologico del nuovo capitalismo.
Il periodo successivo alla crisi del 1981, conseguente la nuova politica economica e monetaria, ma più chiaramente a partire dall’abbandono del cambio fluttuante nel 1987 e fino al crollo del 2007, è stato definito come la già ricordata «Grande Moderazione»: la crescita del prodotto nazionale nei Paesi industrializzati presenta oscillazioni meno marcate rispetto al periodo della Grande Inflazione, anche se negli anni dal secondo dopoguerra fino a metà degli anni Settanta le oscillazioni erano altrettanto poco marcate. La ridotta volatilità del prodotto nazionale è stata spiegata dal ridotto tasso di inflazione nel periodo, e dal ritiro dello Stato dalla politica economica, nonché dal miglioramento introdotto dalla rivoluzione informatica, che ha stabilizzato le politiche aziendali sul magazzino (operare in tempo reale ha ridotto notevolmente sia i volumi degli stock sia il loro ciclo). Ma, allora, le nuove politiche monetarie, che si fondano sull’intuizione di Friedman, per il quale la stabilità monetaria è funzione delle aspettative inflazionistiche degli operatori, sarebbero non solo efficaci per ridurre l’inflazione, ma anche efficienti perché tenderebbero a minimizzare il ciclo: ne deriverebbe che battere l’inflazione equivale a creare le condizioni per una crescita regolare del prodotto — un sogno sul quale si fonda lo statuto della Banca Centrale Europea. Peccato che in una lunga parte del periodo, la moneta pubblica, alla quale si riferisce il pensiero di Friedman, sia stata sostituita da una gigantesca emissione di moneta privata, e questa avrebbe ben potuto produrre inflazione, se non si fossero manifestate le straordinarie crescite dei Paesi emergenti, come già indicato: né la crescita della moneta endogena né lo sviluppo dei Paesi emergenti sono chiamati in causa per spiegare la Grande Moderazione. È, invece, il nuovo capitalismo che, spontaneamente, attraverso l’economia del «leverage» e l’accumulazione, produce una crescita stabile del prodotto mondiale, essenzialmente dominata dai Paesi emergenti. Questa interpretazione attende una conferma statistica; ma la fine della Grande Moderazione, non spiegabile né con le politiche delle banche centrali né con l’informatica, smentisce le interpretazioni tradizionali.” (pag. 182).
“La globalizzazione non elimina le strutture pubbliche, può limitarne il raggio d’azione e renderle servizievoli nei confronti dei capitalisti; poiché lo Stato è struttura originaria, più del capitalismo, può cambiare forma ma non autodistruggersi. Sono molti i modi attraverso cui lo Stato protegge la propria esistenza, ma tutti devono assicurare una qualche capacità di osservazione sull’economia nel suo complesso. Ne segue che per quanto servizievole, lo Stato deve promuovere o accettare un compromesso con i capitalisti, soprattutto allo scopo di correggerne, anche solo temporaneamente o parzialmente, l’anarchia. Non è un evento frequente, ma un singolo Stato può perdere anche l’istinto di sopravvivenza: le unioni di Stati, le federazioni e le confederazioni, gli stessi trattati e accordi internazionali che regolano le sovranità, risultano dal deperimento di qualche formazione di Stato nazionale (feudale, confessionale, tirannico) precedente, ma restaurano sempre una forma di Stato. È anche vero che la pressione dei capitalisti verso lo Stato minimo, che spinge gli Stati a qualche forma di unione, non ne spegne l’ansia di esistere: un buon esempio è l’Unione Europea, che oscilla tra il desiderio di diventare una federazione e il mantenimento di singole sovranità nazionali, ma, pur finendo per esaltare la propria burocrazia e umiliare continuamente la sovranità del proprio parlamento, sopravvive. Meno estremo, ma pur sempre un indizio nella stessa direzione, è il maggior ruolo degli Stati negli Usa, rispetto al governo federale, dopo la Presidenza Reagan.
Nella globalizzazione, con governi che sono sempre tentati dal mercantilismo e con Stati che proteggono la propria esistenza, si materializza un conflitto tra Stati: in assenza di una qualsiasi egemonia planetaria, si oscillerebbe continuamente tra forme di violenza mercantilistica o autoritaria e accordi provvisori fondati sulla cultura liberista dei capitalisti finanziari. La «free trade area» dell’Atlantico è un esempio recente di questa oscillazione, considerando che la moneta di riserva resterebbe il dollaro; ma poiché nel passato mercantilismo e protezionismo hanno sempre trovato nuove vie per aggirare i trattati liberoscambisti, gli accordi regionali non sostituiscono un vero accordo internazionale su nuove basi.” (pag. 221-222).