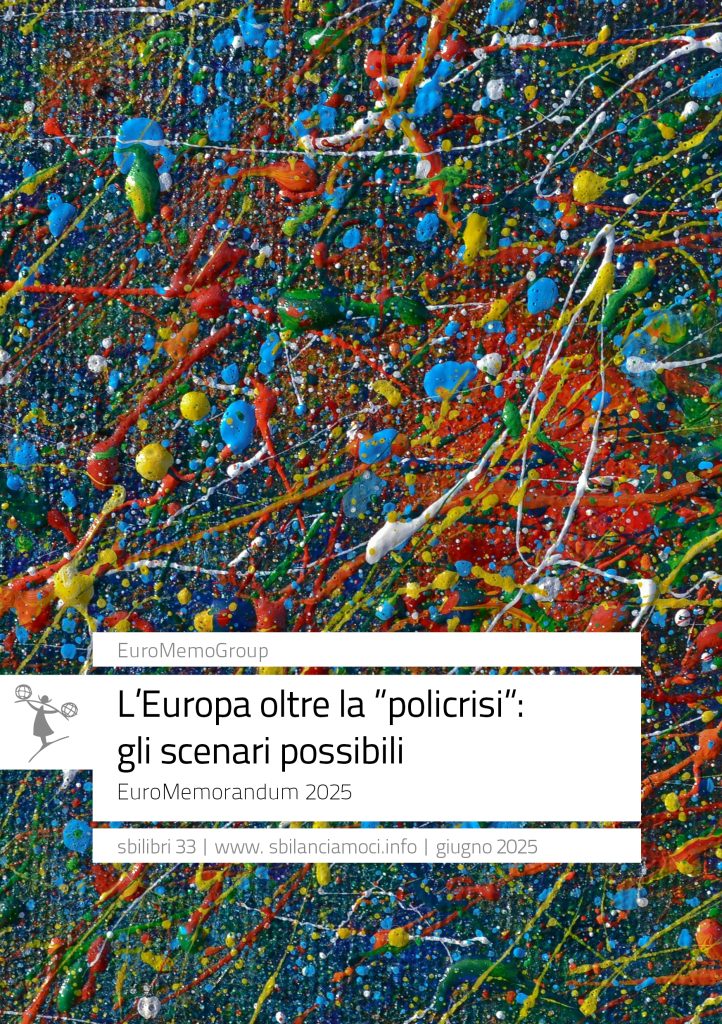Una disintegrazione dell’Europa per le spinte populiste, l’emergere di un nazionalismo europeo, una UE con un ruolo globale, una maggiore capacità di contribuire alle trasformazioni mondiali e, infine, un’Europa che deve affrontare crisi mondiali sempre più gravi e disastrose. Questi i cinque scenari alternativi.
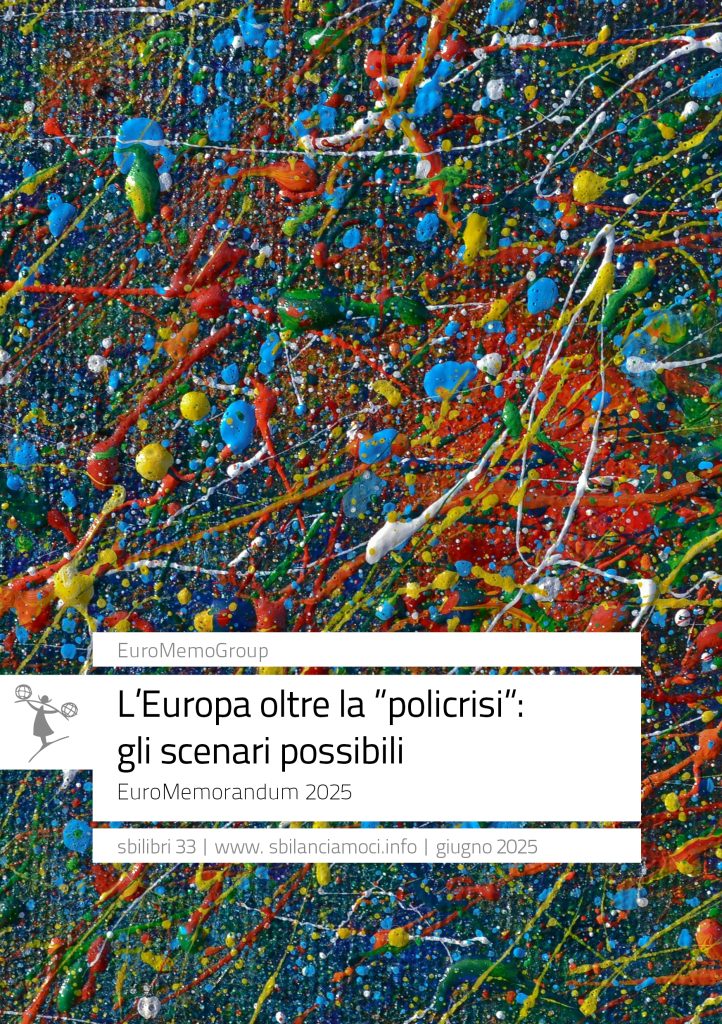
Scenario 1. L’UE si disintegra ulteriormente. Come molti economisti sostengono da decenni, la tendenza, spinta dall’austerità, verso un basso livello di investimenti – nonostante i tentativi di finanziarizzare ulteriormente l’economia e di usare il denaro pubblico per favorire gli investimenti privati – tende ad essere accompagnata da un’elevata disoccupazione e da un aumento delle disuguaglianze. In queste condizioni, è probabile che si verifichino nuove crisi. Queste politiche economiche, unite alle elevate disuguaglianze e al diffuso senso di insicurezza esistenziale, rafforzano le tendenze al populismo autoritario. In questo scenario, si assiste a una lotta tra due forme di nazionalismo: il vecchio (nazionalismo degli Stati membri) e il nuovo (nazionalismo europeo). Se le cause politico-economiche porteranno a un’effettiva, ulteriore disintegrazione dell’UE o al rafforzamento di un nuovo nazionalismo europeo dipenderà da molti fattori, tra cui la tempistica e la natura della prossima recessione o crisi e le precise posizioni di bilancio dei singoli Stati membri in quel momento.
In questo primo scenario prevalgono le vecchie forze nazionaliste e la disintegrazione dell’UE potrebbe continuare nella seconda metà degli anni 2020 o 2030, nonostante i tentativi di aumentare la competitività dell’UE, di rafforzare la sua autonomia strategica aperta e altri tentativi proposti nel Rapporto Draghi. È probabile che le forze vetero-nazionaliste prevalgano anche perché l’accumulazione di capitale e la crescita economica dipendono ancora dagli interessi nazionali e un “capitale europeo” è, nella migliore delle ipotesi, solo in fase di costruzione. Sebbene esistano grandi imprese europee, spesso rimangono ancorate a livello nazionale; e senza l’unificazione della politica fiscale e del diritto del lavoro, il capitale rimane in larga misura legato agli Stati nazionali piuttosto che all’UE. Senza un capitale unificato a livello europeo, anche le lotte dei lavoratori e dei sindacati rimangono in gran parte nazionali, limitando il potenziale di un movimento sindacale a livello europeo. La disintegrazione dell’UE indebolirà ulteriormente l’alleanza occidentale e la NATO. Le forze nazionaliste-populiste sono meno impegnate nei confronti dei valori dell’ordine internazionale liberale che un tempo era guidato dagli Stati Uniti, che a sua volta è diventato un partner inaffidabile a causa della seconda presidenza di Donald Trump ispirata dal motto “America-first”.
Scenario 2. Il crescente nazionalismo rinforza la coesione interna dell’UE. Nel contesto della nuova militarizzazione mondiale, e dato il miope nazionalismo degli Stati Uniti, le minacce esterne e i nemici comuni portano la UE a unificarsi maggiormente. All’inizio si cerca di farlo senza apportare modifiche sostanziali ai Trattati Europei, ma col tempo le modifiche ai Trattati potrebbero essere considerate necessarie. È infatti improbabile che si possa creare un “capitale europeo” senza bilanci UE molto più consistenti e una politica fiscale comune: sta diventando evidente che entrambi sono necessari per investimenti su larga scala nei settori militare e della difesa. In questo scenario, l’UE sviluppa selettivamente alcuni poteri e capacità federali e diventa, passo dopo passo, un giocatore nel gioco globale delle grandi potenze continentali. I processi che ne derivano non sono solo contraddittori, ma comportano anche antagonismi, a partire dalla lotta tra spese militari e sociali da parte dei governi. Anche se in un primo momento il multilateralismo globale selettivo persisterà in alcune aree, dato l’unilateralismo dello Stato leader (gli Stati Uniti) e le risposte sempre più unilaterali ad esso, nonché le relative dinamiche negative dell’economia mondiale, la competizione e le guerre commerciali tra gli Stati si intensificheranno e si svilupperanno nuovi blocchi regionali (che potrebbero evolvere in super-Stati) e conseguenti alleanze – aprendo così la strada a un disastro globale.
Scenario 3. L’UE diventa un attore globale della trasformazione. Lo sviluppo e il dominio nell’ultimo mezzo secolo delle teorie economiche e politiche del neoliberismo, nonché l’ascesa di qualcosa che ricorda l’imperialismo del periodo 1871-1914, sono stati resi possibili da politiche strutturalmente condizionate dall’oblio e dal ricordo unilaterale che hanno gradualmente annullato molte delle lezioni storiche del passato. Tuttavia, molti intellettuali pubblici, attori della società civile (tra cui lo stesso EuroMemoGroup) e partiti (forse soprattutto il DiEM25) hanno sviluppato e propugnato alternative europee e globali che favorissero l’apprendimento cognitivo, etico-politico e istituzionale su scala regionale e globale. Gli sforzi in questa direzione possono essere caratterizzati come democratici e global-keynesiani (considerando quest’ultimo termine una combinazione di molti filoni di pensiero politico ed economico). In altre parole, nella storia europea recente molto è già stato appreso, ma la tendenza collettiva a dimenticare rimane uno dei problemi.
Quanto è possibile e probabile che l’UE adotti una teoria economica keynesiana globale e il tipo di teoria morale senza limiti che richiede l’apertura di spazi politici democratici e la promozione di pratiche democratiche anche nella governance globale? I principi ufficiali dell’UE sono stati fondati sulle politiche economiche neoliberiste e sulla loro approvazione tecnocratico-funzionalista. A meno che questi principi radicati non vengano modificati, l’UE non sarà in grado di promuovere principi alternativi nella politica mondiale. Né il keynesismo democratico-globale deriverebbe direttamente dalla costruzione di un’UE più federale. Una federazione nazionalisticamente separata ed eurocentrica incontrerà gli stessi problemi e paradossi economici di qualsiasi Stato sovrano, derivanti da una prospettiva non adeguatamente generalizzabile. Quanto più eurocentrica e miope è la percezione che la nuova federazione ha di sé, tanto più è probabile che diventi parte delle condizioni prevalenti dell’economia mondiale, con tutte le loro contraddizioni intrinseche. È quindi probabile che i progressivi cambiamenti all’interno dell’UE richiedano un impulso o una crisi esterna.
Scenario 4. L’UE viene coinvolta in un più ampio processo di trasformazioni globali. Le future trasformazioni europee e globali potrebbero seguire una sequenza proattiva: la società civile ampiamente concepita, forse coinvolgendo nuove soggettività come i partiti politici europei e globali, insieme a leader riformatori che emergono dall’interno delle strutture di potere esistenti, può sorgere come forza spontanea. Tuttavia, nelle forme prevalenti della società di mercato capitalista, anche nel contesto della governance globale, esistono ostacoli a tali sviluppi. La tendenza alla frammentazione e alla superficialità può essere particolarmente forte nelle condizioni di una divisione globale del lavoro, in una società orientata alla massimizzazione del profitto e al soddisfacimento dei bisogni individuali. Per decenni, tali caratteristiche sono state fortemente rafforzate dal neoliberismo.
Anche se possibile, è improbabile che i processi di apprendimento a lungo termine siano sufficienti da soli a creare le condizioni per l’ascesa dei movimenti globali come forza spontanea di cambiamento nei prossimi anni. Il successo dell’organizzazione di azioni collettive e di qualcosa di analogo alle precedenti forme di “coscienza di classe” spesso richiede (i) un episodio drammatico vissuto simultaneamente da molti attori e (ii) la prevalenza o l’emergere della speranza intesa in termini di storie ampiamente condivise su migliori possibilità future. Lo sviluppo della coscienza aiuta a superare le contraddizioni specifiche di ogni momento del processo di organizzazione delle azioni collettive (realizzazione del problema o della contraddizione, tentativi di organizzare l’azione collettiva, sviluppo dell’identità e della solidarietà, cambiamenti istituzionali). Le crisi economiche e le guerre, così come i disastri ambientali, possono contemporaneamente rafforzare l’idea che il cambiamento è necessario e abbassare il costo della cooperazione, poiché gli attori sanno che molti altri la pensano come loro e vedono molti di loro unirsi per ottenere una trasformazione. L’incontro di molti attori crea anche legami di fiducia e solidarietà e quindi una base per nuove identità e forme di organizzazione. Nel contesto di una minaccia acuta o di una crisi che colpisce la vita quotidiana delle persone, gli attori che seguono copioni incompleti sulle proprie scelte morali possono anche imparare a raccontare nuove storie; possono quindi passare rapidamente da un livello di coscienza e da un momento di organizzazione delle attività collettive a un altro – anche quando la crisi non si è ancora verificata o la catastrofe è avvenuta.
Scenario 5. Ulteriori crisi economiche o ecologiche e guerre creano uno slancio per i movimenti di riforma. Nella sua accezione più generale, la crisi indica un potenziale punto di svolta in un processo, che decide se un’identità o un sistema esistente continuerà così com’è, si trasformerà o addirittura cesserà di esistere per essere sostituito da qualcos’altro. Una crisi offre infatti una possibilità di apprendimento, come nel detto cinese secondo cui ogni crisi è sia una minaccia che un’opportunità. Sebbene non vi sia motivo di pensare che l’attuale situazione di stallo della governance globale non possa essere superata in ambito economico, il contesto attuale deve diventare marcatamente diverso sotto alcuni aspetti significativi perché tale cambiamento sia possibile.
Negli anni 2020 o 2030, può emergere un diffuso senso di crisi a causa di una rapida accelerazione del cambiamento climatico, di una crisi economica o di una grande guerra. Questi fattori possono portare a una percezione ampiamente condivisa di un’imminente catastrofe globale. L’evidenza di un disastro imminente è tanto più convincente quanto più è palpabile, anche se da un punto di vista razionale non è in alcun modo giustificato aspettare che un processo ragionevolmente prevedibile porti a conseguenze catastrofiche. Consideriamo i seguenti sotto-scenari: (i) i costi umani ed economici degli eventi meteorologici estremi legati al riscaldamento globale aumenteranno fino a 10 o 50 volte il livello attuale; (ii) la Corrente del Golfo perderà la sua forza e il clima dell’Europa settentrionale diventerà radicalmente più freddo di quello attuale; oppure (iii) si verificherà una guerra nucleare limitata sull’Ucraina, su Taiwan o tra India e Pakistan, con un lungo inverno nucleare che cambierà radicalmente le circostanze del pianeta per almeno un decennio. Sono plausibili anche diversi altri sotto-scenari simili. L’evidenza di una catastrofe imminente o le esperienze di tale catastrofe solleciteranno sforzi di trasformazione da parte dei movimenti sociali, della comunità di ricerca, delle organizzazioni internazionali e di alcuni governi. Tuttavia, la realizzazione di cambiamenti su larga scala richiede tempo, da anni a decenni.
Inoltre, i cambiamenti nei contesti della vita quotidiana e i mutamenti prevalenti nelle forme e nelle storie della coscienza indicano una graduale transizione culturale. Ma i cambiamenti avvengono anche a un livello più concreto. Una svolta nella governance globale nel campo della sicurezza o dell’ambiente, che comporti una critica delle spiegazioni causali, delle teorie, delle idee e delle storie prevalenti, influenzerà anche il campo dell’economia, anche perché il riconoscimento del ruolo dell’economia politica nella sicurezza e nell’ambiente è una parte probabile di questo processo di apprendimento.
L’UE si sta vincolando sempre più in un processo di corsa agli armamenti globale tra coalizioni o alleanze militarizzate di Stati. Questa dinamica ha già portato il mondo molto avanti verso un’era di “guerra fredda” generalizzata. Gli sviluppi attuali hanno un potenziale reale di catastrofe militare globale. Pertanto, nella situazione attuale, non esiste un’alternativa ragionevole al dialogo, alle misure di costruzione della fiducia, alle concessioni reciproche e alla de-escalation delle guerre in corso. Molte delle riforme più importanti degli anni 2020 e 2030 riguardano la governance dell’economia mondiale, gli sviluppi tecnologici e i problemi ecologici. Trasformazioni interconnesse e sovrapposte in termini di sistemi di governance globale possono contribuire a trasformare il contesto generale, consentendo così di stabilire norme e principi fondamentalmente nuovi, non da ultimo per quanto riguarda il controllo delle armi di distruzione di massa e la lotta al cambiamento climatico. Il futuro dell’umanità dipende dalla nostra capacità di imparare (anche dalla storia) e di costruire istituzioni comuni su basi sostenibili e legittime.