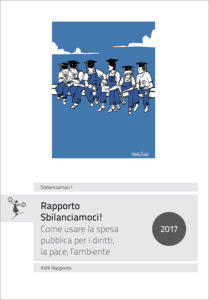A giugno la Commissione europea ha stimato che l’introduzione di una vera e propria Tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe fruttare all’Italia 16,3 miliardi di euro l’anno

L’ennesimo anno difficile, per non dire di peggio, per le banche italiane. Il 2016 si apre con la vicenda di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Cari Chieti, che per molti risparmiatori ha significato pesanti perdite, rabbia, frustrazione.
Non si fa in tempo a trovare una soluzione che esplode il caso delle due popolari venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E poi la delicatissima situazione di Monte dei Paschi di Siena e i problemi di diverse altre banche. Problemi legati in primo luogo alle sofferenze, ovvero all’ammontare di prestiti che non vengono restituiti e pesano sui bilanci delle banche. A questo si accompagnano spesso inefficienze e costi fissi eccessivi. Diversi motivi di fragilità intrinseca, a cui si somma un perdurante pessimo andamento dell’economia e una crisi di fiducia.
La solidità di una banca si misura principalmente in rapporto al suo patrimonio. Se si sparge la voce che una banca è in difficoltà, il valore delle azioni crolla aumentando queste stesse difficoltà in una spirale che si auto-alimenta. Per uscirne ci sono, in teoria, diverse strade. Prima di tutto si può provare a rimuovere la causa della sfiducia. Si possono leggere così gli sforzi per liberare le banche italiane almeno da una parte delle loro sofferenze, così come la scelta dell’Associazione Bancaria Italiana di divulgare unicamente i dati sulle sofferenze nette e non su quelle lorde, in modo da fornire dati più rassicuranti.
Una seconda possibilità di intervento consiste nel rafforzare il patrimonio delle banche in difficoltà
Difficile però convincere gli investitori a puntare i loro soldi su banche in equilibrio precario. Si può allora pensare di immettere capitali pubblici per rafforzare il patrimonio. È la strada perseguita da molti Paesi occidentali all’indomani della crisi dei subprime e ancora negli ultimi anni, ma è anche uno dei maggiori elementi di frizione tra Roma e Bruxelles, a causa del rischio di aiuti di Stato che potrebbero violare le “sacre regole” del libero mercato e della concorrenza.
Le nuove regole entrate in vigore all’inizio dell’anno – in particolare il cosiddetto “bail-in” – prevedono che, in caso di crisi bancaria, prima gli azionisti, poi eventualmente anche i titolari di alcune obbligazioni e in ultimo i grandi clienti possano essere chiamati a coprire le perdite. Solo se questi interventi non dovessero bastare si può pensare, in ultima istanza e in situazioni eccezionali, a un intervento pubblico. Il problema – come Banca Etruria e le altre hanno ampiamente dimostrato – è che toccare il risparmio degli italiani ha delle pessime ricadute sul piano politico.
Nel 2016 il caso più grave è quello di Monte dei Paschi di Siena, soprattutto dopo gli stress test della Bce e la lettera che ha chiesto alla banca senese di ridurre entro tre anni le sofferenze lorde dai 46,9 miliardi di fine 2015 a 32,4, e quelle nette da 24,2 a 14,6. Quasi 10 miliardi di sofferenze nette di cui disfarsi. Da qui il tentativo del Governo di varare un piano che convinca i mercati, eviti il bail-in e non incorra nelle reprimende di Bruxelles sugli aiuti di Stato. Un piano da 5 miliardi di ricapitalizzazione e, appunto, quasi 10 miliardi di sofferenze da liquidare.
Riguardo alla ricapitalizzazione – la presenza di investitori che mettano soldi freschi per comprare azioni – ricordiamo che i precedenti aumenti di capitale sono stati massacrati dai crolli in Borsa. In due anni le azioni del Monte dei Paschi sono passate da 5,61 a meno di 0,3: una perdita intorno al 95%. Difficile pensare che degli investitori, senza ulteriori garanzie, possano decidere di riprovarci. Per questo serve un risanamento, ovvero ridurre le sofferenze. Esistono diversi soggetti finanziari che acquistano crediti deteriorati a prezzi scontati, per poi cercare di rientrare del possibile.
Quanto valgono però, secondo il mercato, questi crediti deteriorati? La cosa dipende da una pluralità di fattori. Per dirne uno, se i potenziali acquirenti sanno che una banca è sull’orlo del precipizio e ha il fiato sul collo sia del Governo che non vuole il bail-in sia della Bce, è molto facile che il prezzo di acquisto crolli. Il problema è che se il valore delle sofferenze crolla, non è più quello che è stato messo a bilancio. Il nuovo valore, molto più basso, comporterebbe un ulteriore buco di bilancio, che la banca non può permettersi, perché le perdite rischierebbero di azzerare il capitale, il che significa arrivare appunto al bail-in. Ecco allora che in un modo o nell’altro, il pubblico deve intervenire, in maniera più o meno indiretta.
Nel caso della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca è intervenuto il Fondo Atlante, per Monte dei Paschi si parla di Atlante 2. Atlante è stato creato con soldi provenienti da banche, fondazioni, assicurazioni e da Cassa Depositi e Prestiti. Formalmente privato per non violare le regole europee sugli aiuti di Stato, è stato utilizzato per acquistare la quasi totalità del capitale delle due banche venete. Per la banca senese il meccanismo sarebbe diverso: Atlante 2 dovrebbe comprarne le sofferenze a un prezzo superiore a quello di mercato. Ciò permetterebbe di non dover ulteriormente svalutare le sofferenze a bilancio, quindi di non creare nuovi buchi e anzi di ripulire il bilancio stesso, il che dovrebbe poi invogliare gli investitori a sottoscrivere un nuovo aumento di capitale.
Perché, tuttavia, qualcuno dovrebbe comprare le sofferenze a un prezzo superiore a quello di mercato? Le banche italiane potrebbero sottoscrivere capitale di Atlante 2 sia perché “cortesemente invitate” dal Governo a farlo, sia per evitare che un disastro in Monte dei Paschi possa causare un effetto domino sull’intero sistema bancario. Cassa Depositi e Prestiti, anche se formalmente soggetto privato, è controllata dal Ministero dell’Economia. Qualche ente potrebbe anche investire pensando che alla fine il fondo riuscirà a recuperare crediti per un valore superiore a quello di acquisto delle sofferenze.
Difficile quindi stimare se in futuro ci potrà essere un impatto sui conti pubblici. Rispetto agli interventi prospettati, però, sorge anche un altro problema: tra le sofferenze ci sono molti prestiti fatti negli anni passati a imprese in difficoltà. Nel momento in cui come banca vendo tali crediti a investitori interessati a massimizzare il profitto esercitando ogni possibile azione per rientrare dei prestiti nei tempi più brevi, non rischio di strangolare tali imprese? Se l’obiettivo dei salvataggi
delle banche dovrebbe essere il rilancio dell’economia, non si rischia al contrario di avere impatti fortemente negativi sul tessuto produttivo?
Peraltro, al di là di tutto, il centro dell’attenzione del legislatore in Italia e in Europa non dovrebbe essere su come riuscire a salvare il sistema finanziario da se stesso, ma su come renderlo uno strumento efficace al servizio dell’economia produttiva. Non si dovrebbe ragionare soltanto su cosa fare in occasione della prossima crisi e su quali meccanismi di salvataggio mettere in campo, ma su come evitare che le crisi si manifestino con questa frequenza. In altre parole, servono regole e controlli per rendere il sistema bancario e finanziario più solido e resiliente, intervenendo a monte e non unicamente a valle, dopo lo scoppio delle crisi.
È in questa direzione che da anni reti e organizzazioni della società civile chiedono l’introduzione di alcune regole chiare: la separazione tra banche commerciali e di investimento, limiti ai bonus dei manager bancari, una Tassa sulle Transazioni Finanziarie, una seria lotta ai paradisi fiscali. Ancora, bisognerebbe riconoscere che diversi modelli di fare banca possono e devono coesistere, anche per rispondere a diverse necessità della società e del sistema economico e produttivo. Questa “biodiversità bancaria” viene invece ignorata, se non ostacolata, in un’Europa “a taglia unica”, dove le regole sono cucite sui gruppi bancari di maggiore dimensione.
È complicato stimare l’impatto sui conti pubblici di queste misure. Molte non ne avrebbero direttamente, anche se nel medio periodo permetterebbero con ogni probabilità sia un migliore funzionamento dell’economia sia di evitare continui interventi pubblici al capezzale delle banche in crisi. L’unica proposta quantificabile in termini di maggiori entrate, ovvero la Tassa sulle Transazioni Finanziarie, è riportata di seguito.
Le proposte di Sbilanciamoci!
Introduzione di una vera Tassa sulle Transazioni Finanziarie
Il Governo Monti ha introdotto nel 2012 una misura denominata “tassa sulle transazioni finanziarie”, ma lontanissima dalla proposta avanzata dalle reti europee e oggi in discussione fra 10 Paesi dell’Unione Europea che ne stanno negoziando l’architettura sotto la procedura di cooperazione rafforzata.
La versione italiana si applica solo ad alcune azioni e alcuni derivati sulle azioni e, nel caso azionario, solo ai saldi di fine giornata, non alle singole operazioni. Non si tassano gli strumenti più speculativi e non si disincentiva l’intraday trading azionario, in particolare il regime di negoziazione ad alta frequenza, il più dannoso. In termini di gettito, la misura italiana ha generato lo scorso anno 480 milioni di euro. A ottobre 2016 i Paesi della cooperazione rafforzata, hanno raggiunto un accordo sui 6 macropilastri dell’architettura della Tassa sulle Transizioni Finanziarie (Ttf) europea, ponendosi come obiettivo di consolidare il testo legale della direttiva entro giugno 2017. A giugno 2016 la Commissione Europea ha stimato che la Ttf potrebbe generare nei 10 Stati al centro del negoziato un gettito di circa 86,4 miliardi di euro annui, e in particolare 16,3 miliardi di euro l’anno per l’Italia. È però una stima onnicomprensiva, con oltre 48 miliardi annui attribuibili alla tassazione di strumenti (i long-term debt instruments e i repos e reverse repos) che questi Stati sono orientati a tenere fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta europea.
Lo stesso documento della Commissione quantifica peraltro in circa 22,2 miliardi di euro le stime per i 10 Paesi (4,2 miliardi annui per l’Italia) del gettito di una Ttf che rispecchia l’avanzamento dei lavori negoziali e l’architettura dell’imposta che sta emergendo. Si tratta verosimilmente anche del target erariale verso cui si orienteranno gli Stati Membri nella fase conclusiva del negoziato (e nella scelta delle aliquote). La mancanza a oggi di tale misura non dipende da motivi tecnici quanto da volontà politica. Consideriamo quindi il gettito che si sarebbe potuto avere già quest’anno con l’introduzione di una “vera” Ttf: sottraendo ai 4,2 miliardi stimati per l’Italia i circa 500 milioni della Ttf nazionale che cesserebbe di essere applicata, si arriva a un extra gettito di 3,7 miliardi annui.
Maggiori entrate: 3.700 milioni di euro