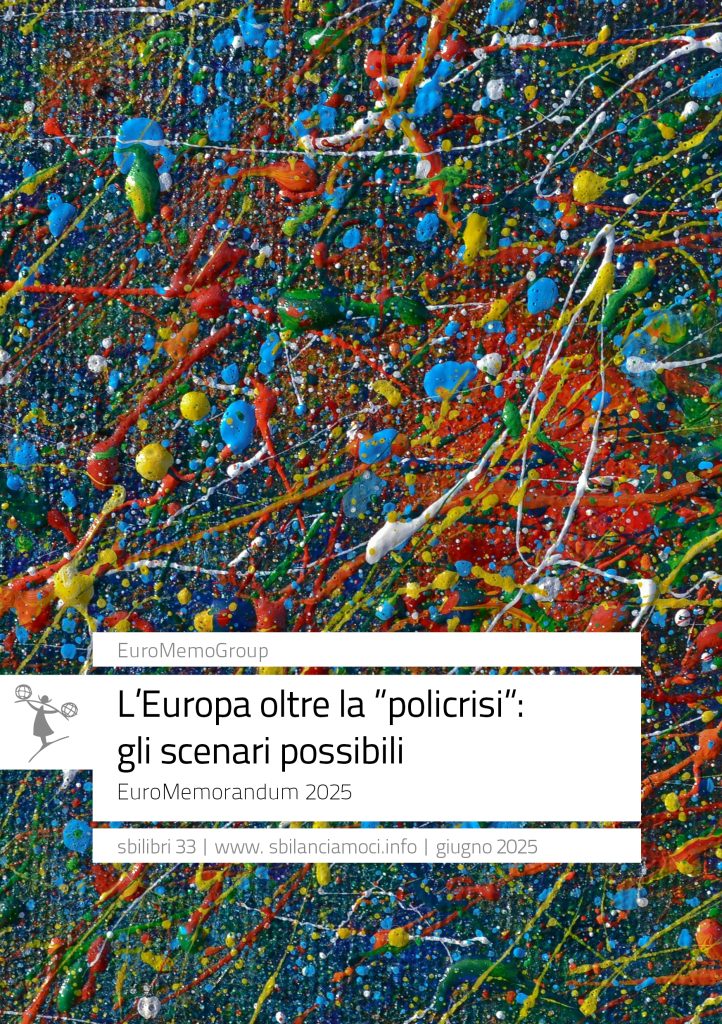È da trent’anni che l’EuroMemoGroup – rete di economisti – pubblica un rapporto sullo stato dell’Europa, e da 13 anni Sbilanciamoci! partecipa alla preparazione e lo traduce in italiano. Pubblichiamo ora l’edizione 2025, liberamente scaricabile, dedicata a come si può uscire dalla “policrisi” di oggi.
Per scaricare l’e-book compila il modulo:
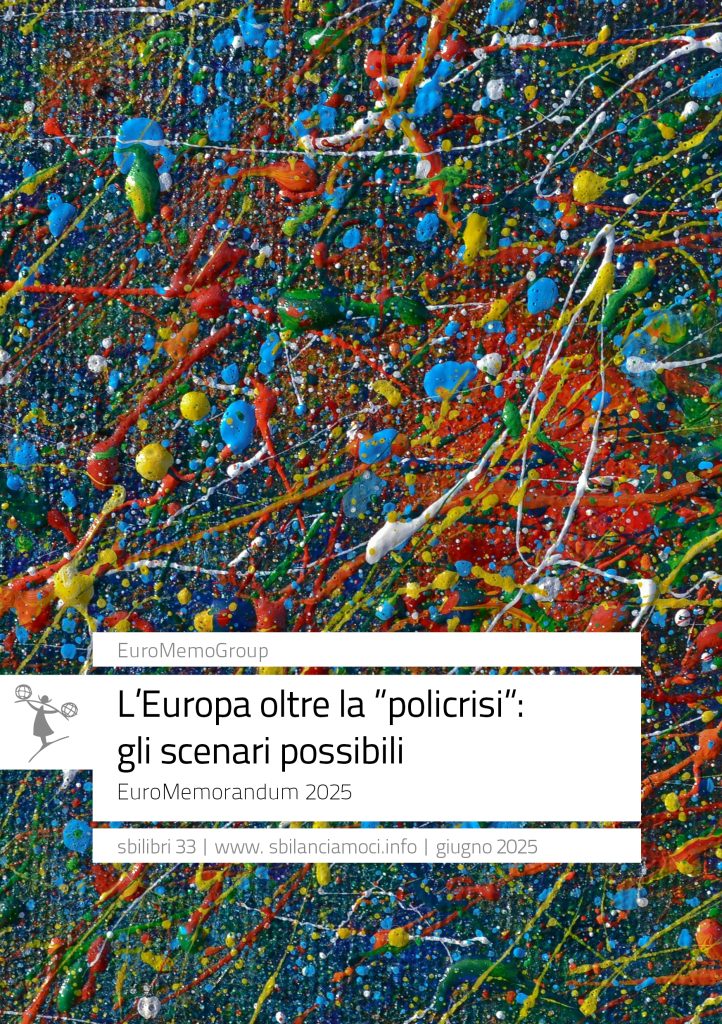
La gravità delle molteplici crisi globali – la “policrisi” – è oggi sotto gli occhi di tutti, ma è molto più difficile identificare i possibili scenari futuri. È ciò che tenta di fare l’EuroMemoGroup, rete di economisti e scienziati sociali per una politica economica europea alternativa, nell’Euromemorandum 2025. Si tratta della 30ma edizione di questo rapporto, tradotto da Sbilanciamoci! per il tredicesimo anno consecutivo. In occasione dei 25 anni dall’introduzione dell’euro, la UE ha prodotto una serie di rapporti che guardano agli sviluppi a lungo termine dell’Europa, come l’Agenda strategica del Consiglio europeo, gli Orientamenti politici del Presidente della Commissione europea, la Relazione Letta e soprattutto il Rapporto Draghi. Come risposta, l’EuroMemoGroup presenta nell’Euromemorandum 2025 la sua visione dell’Europa e del mondo su un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello dei prossimi dodici mesi.
L’analisi della situazione dell’UE parte dalle preoccupazioni sulla “policrisi” e da alcuni elementi positivi. L’inflazione è scesa nel 2024 grazie al calo dei prezzi dell’energia, e i tassi di occupazione sono aumentati in modo rilevante. Inoltre, nella maggior parte dei paesi, la nuova occupazione si manifesta prevalentemente sotto forma di contratti di lavoro stabili. Sono state emanate la direttiva sul lavoro sulle piattaforme digitali e la direttiva sul salario minimo, che dovrebbero migliorare la protezione dei lavoratori se recepite e pienamente attuate. Anche i salari minimi sono aumentati nell’UE in termini reali. Il contributo alla ripresa post-pandemia da parte di Next Generation EU (NGEU) ha dimostrato il potenziale degli strumenti fiscali europei. Attualmente il Recovery Plan sta svolgendo un ruolo importante nel sostenere gli investimenti pubblici che contrastano la grave riduzione degli investimenti privati. La ripresa è stata relativamente forte in alcuni Paesi della periferia dell’UE, tra cui Spagna, Polonia, Croazia, Malta e Cipro.
Tuttavia, nel 2024 l’economia europea nel suo complesso ha registrato il secondo anno consecutivo di stagnazione e la Germania il secondo anno di caduta del Pil. Il tasso di crescita dell’occupazione è in calo. Tutto indica i rischi che si corrono facendo affidamento, come fa l’UE, sugli investimenti privati e sulla crescita trainata dalle esportazioni. La contrazione degli investimenti privati è stata la principale causa dell’attuale stagnazione, alimentata dall’instabilità geopolitica, con le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Mentre viene pubblicato l’EuroMemorandum di quest’anno, gli Stati Uniti di Donald Trump annunciano dazi sul commercio con la UE. Le condizioni di salute, sicurezza e lavoro per i cittadini europei si stanno deteriorando nel periodo post-pandemia, con effetti particolarmente negativi per le donne.
Alla luce di questi sviluppi, è stato un grave errore introdurre il 30 aprile 2024 la riforma del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) dell’UE. Se pienamente attuato, il PSC porterebbe a un ritorno a una politica fiscale rigida e restrittiva chiudendo la parentesi di una politica fiscale più flessibile e anticiclica sperimentata durante la pandemia di Covid-19. Ciò aggraverebbe le spinte verso la stagnazione e gli squilibri; non è di questo che l’UE ha bisogno nel nuovo clima geopolitico e di fronte alla trasformazione socio-ecologica che è necessaria per affrontare il cambiamento climatico. Non si prevede inoltre che il Recovery Plan possa proseguire oltre la sua attuale durata. Per contro, la politica monetaria si è allentata, ma è improbabile che possa contrastare il ritorno all’austerità fiscale. Tuttavia, il PSC riformato potrebbe non superare l’anno a causa degli sviluppi geopolitici, con il Libro Bianco Readiness 2030 che raccomanda la riattivazione della “General Escape Clause” (ossia la clausola di deviazione temporanea dagli obiettivi di medio termine del PSC) per le spese militari e la mutualizzazione dei prestiti per questi scopi. A quanto pare, le regole europee sono più facilmente accantonate per la militarizzazione – con effetti moltiplicativi più deboli – che per la trasformazione socio-ecologica.
Riconoscendo il fallimento della “politica della concorrenza” nell’arrestare il declino dell’UE rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, si è assistito a una rinascita della politica industriale nell’UE, almeno a livello discorsivo. Questi sviluppi sono valutati nell’Euromemorandum con particolare attenzione ai Programmi Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) del NGEU. Nel complesso, questi sviluppi sono stati deludenti per la loro mancanza di direzione strategica e di responsabilità democratica. Essi operano essenzialmente come sostegno all’accumulazione guidata dalla finanza e alle strategie di svalutazione interna. È inoltre preoccupante che la politica industriale sia sempre più militarizzata. Il lato positivo è che i PNRR hanno portato a una maggiore autonomia locale rispetto alla Troika, e in alcuni casi hanno facilitato gli investimenti strategici nella transizione verde e digitale. In altri casi, tuttavia, si è verificata una totale mancanza di direzione e si è verificato un compromesso tra la responsabilità nazionale e locale e il coordinamento a livello europeo. Nel complesso, sono necessarie ulteriori ricerche per valutare gli effetti della politica industriale dei PNRR e del NGEU.
L’Euromemorandum 2025 propone quindi le seguenti alternative per le politiche europee:
- Un consistente piano di investimenti a livello europeo, in stretto coordinamento con i corrispondenti piani nazionali, per promuovere la trasformazione socio-ecologica e accelerare la trasformazione tecnologica nel settore industriale dell’UE.
- Un quadro di governance fiscale alternativo che includa una “regola aurea”, che escluda dal pareggio di bilancio gli investimenti pubblici netti finalizzati alla trasformazione socio-ecologica, nonché regole di sostenibilità del debito che prestino attenzione al costo del servizio del debito pubblico rispetto al PIL, piuttosto che al suo livello.
- Politiche sociali e fiscali redistributive, con un reddito e un’occupazione adeguati che offrano tutele adeguate contro la povertà e l’esclusione sociale.
- Salari equi e dialogo sociale, con maggiore trasparenza retributiva e migliori condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.
- Nuove regole per il mercato del lavoro che tutelino i lavoratori, in particolare per il lavoro sulle piattaforme digitali, per il lavoro fintamente autonomo e per il management algoritmico.
I capitoli dell’Euromemorandum riprendono e approfondiscono tematiche trattate in edizioni passate. Rispetto agli sviluppi dell’Unione Economica e Monetaria dell’UE, si sottolinea l’insostenibilità del “business as usual” che non può essere un’opzione adeguata nel lungo periodo. Si torna a criticare la governance economica dell’UE come un modello particolare di neoliberismo e di capitalismo guidato dalla finanza, che ha esteso le privatizzazioni e trasformato in merci nuovi ambiti della vita sociale.
L’alternativa, sostenuta dall’EuroMemoGroup nel corso degli anni, è un’economia della cura che parta dai bisogni sociali; essa contribuirebbe allo sviluppo di un sistema democratico che potrebbe promuovere cambiamenti positivi. In una prospettiva più globale, un cambiamento di paradigma in questa direzione è necessario se l’UE vuole diventare un attore in grado di trasformare il sistema mondiale. L’attuale strategia della UE basata sull’idea di una “crescita verde”, come quella del Green Deal europeo (EGD) e delle politiche ad esso collegate, anche se attuata correttamente, non sarebbe generalizzabile a scala globale e implica una domanda sproporzionata rispetto alle risorse naturali e alla forza lavoro del pianeta. Si fonda ancora sul ruolo privilegiato dell’Europa nel sistema mondiale – un potere che si è affermato a partire dal XVI secolo – e riflette un “modo di vivere imperiale”.
Queste analisi critiche si collegano direttamente al Rapporto Draghi. L’Euromemorandum 2025 critica il Rapporto Draghi per i fallimentari tentativi di copiare il modello di sviluppo americano – finanziarizzazione, stimolo dell’economia dal lato dell’offerta – ma senza un bilancio federale di grandi dimensioni a scala europea e proponendo un concetto di “autonomia strategica aperta” che può significare praticamente qualsiasi cosa. Inoltre, il Rapporto Draghi prospetta un pericoloso aumento della militarizzazione, dell’autoritarismo, dei rapporti tra Stati basati sulla forza delle armi. In sintesi, il Rapporto Draghi egli altri documenti della UE analizzano i cambiamenti del contesto in cui opera l’Europa e cercano di rispondervi, ma non colgono come le aspettative e gli interventi che vengono delineati possano risultare in un peggioramento della crescita sostenibile, in un aumento delle disuguaglianze, in maggiori antagonismi e all’espansione dei conflitti militari. Come alternativa a questi limiti, l’EuroMemoGroup offre un’analisi complessiva delle dinamiche dell’UE nel sistema globale e propone cinque scenari.