Sette anni dopo la Grande Crisi la crisi il sistema bancario è sempre più fragile e sempre più intoccabile. La seconda puntata della nostra inchiesta
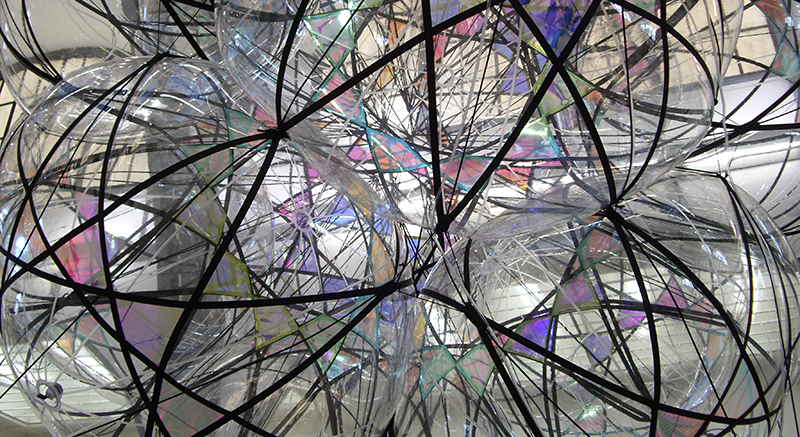
Le difficoltà delle banche sono state scaricate, negli scorsi anni, da una parte sulle casse statali, dall’altra sui lavoratori del settore, mentre i dirigenti delle grandi istituzioni, responsabili della gran parte dei guai, sono usciti sostanzialmente indenni; qualcuno di essi, al massimo, è stato congedato dal suo incarico, ma con liquidazioni milionarie. Intanto il sistema degli incentivi, a suo tempo così perverso, è lungi dall’essere stato ridisegnato come conviene.
Dallo scoppio della crisi ad oggi si sono persi così circa 600.000 posti di lavoro in occidente. Negli ultimi cinque anni solo in Europa sono scomparse 225.000 posizioni e nel solo 2015 i grandi gruppi bancari europei hanno annunciato 130.000 riduzioni di occupati (Chocron, 2015). Tale cifra deriva sia dalla sparizione di decine di migliaia di posti di lavoro che dalla ristrutturazione del perimetro delle attività a livello geografico o settoriale.
L’innovazione tecnologica e lo sviluppo dell’home banking hanno contribuito anche esse alla riduzione degli effettivi.
Banche universali e banche di investimento
Il modello della banca universale prevede che gli istituti, oltre a sviluppare l’attività di banca ordinaria, prendano partecipazioni nelle imprese, sviluppino attività di trading in proprio sui mercati, svolgano consulenza finanziaria per i propri clienti nel reperimento delle risorse, nei processi di emissione di titoli, nelle operazioni di fusione ed acquisizione.
Negli Stati Uniti tale modello non si è potuto affermare sino a tempi recenti, dal momento che il Glass Steagall Act del 1933 aveva imposto la separazione tra le attività di banca ordinaria e quelle di banche di investimento. Ma nel 1999, sotto la presidenza Clinton, il divieto è stato rimosso.
Ma ora tutto sembra rimesso, almeno in parte, in discussione.
Appare chiaro che il modello della banca universale è aperto oggi a degli inconvenienti difficili da superare: da una parte, l’ipotesi illusoria che combinando i differenti mestieri in una sola istituzione si riducano i costi, dall’altra la presa di consapevolezza che l’attività di banca ordinaria e quella di banca di investimento sono due mestieri differenti, che richiedono diverse competenze e talenti (Reed, 2015).
L’investment banking è diventato un business sempre più difficile. BasileaIII e lo stesso governo Usa hanno alzato le richieste di capitale e di liquidità per svolgere molte di tali attività; tra l’altro, le nuove regole richiederanno un livello di mezzi propri molto più elevato di prima per le attività di trading, mentre la concorrenza preme sui margini di profitto. Per altro verso, tale mestiere richiede di fare molte cose differenti in molti posti contemporaneamente e questo è diventato molto difficile (Gapper, 2015).
Negli ultimi tempi si è assistito così a un proliferare di progetti di ristrutturazione da parte delle grandi banche europee, anche perché esse ottengono una redditività che, oltre che in riduzione, è anche inferiore a quella delle banche statunitensi. I nuovi requisiti di capitale le stanno spingendo a concentrarsi nelle attività capital light (consulenza su fusioni ed acquisizioni, e nell’aiutare i clienti a trovare dei capitali sul mercato) e a tralasciare le altre (trading in particolare). Altri istituti continuano a fare tutto, ma di meno (Noonan, 2015). Alla fine, c’è comunque un tema comune per le banche di investimento europee: ritirata (Gapper, 2015).
La riforma
Subito dopo lo scoppio della crisi del 2008 non c’era stato quasi uomo politico in Occidente che non avesse promesso una profonda ristrutturazione del sistema. Ad esempio, Nicola Sarkozy dichiarava nel settembre del 2008: “la crisi dovrebbe portare ad una ristrutturazione di grande ampiezza in tutto il settore bancario mondiale” (Jorion, 2015).
Ma le banche hanno preso le migliaia di miliardi che servivano loro per stare in piedi e hanno subito dopo cominciato a criticare i governi perché volevano cercare di cambiare le cose. Ed esse in effetti non sono cambiate molto. Questo nonostante che negli ultimi anni un’ondata di scandali abbia continuato a mostrare all’opinione pubblica un volto molto poco attraente del settore.
Il dibattito su come cambiare il business si era concentrato su molti punti. Si sottolineava così la necessità che fossero aumentate le basi di capitale e i livelli di liquidità; che si dividessero le attività di banche ordinarie da quella di investimento; che venissero ridimensionati gli istituti too big to fail; che si mettessero sotto controllo una serie di operazioni molto discutibili; che venissero ridimensionati i sempre più vasti business di asset management, gli hedge funds, i fondi di private equity, lo shadow banking; che si rinforzasse il ruolo delle autorità di controllo; che si intervenisse sul perverso sistema di remunerazione dei manager del settore. E l’elenco potrebbe continuare.
Ma le banche hanno cercato, con un rilevante successo, di porre il veto a qualsiasi strategia che non fosse la ricostruzione del sistema in modo sostanzialmente identico a come era prima della crisi.
Comunque con BasileaIII si sono varate delle regole più stringenti per quanto riguarda la solvibilità e la liquidità degli istituti. Ma da più parti si valuta che i nuovi parametri, pur migliori dei precedenti, sono per molti versi ancora insoddisfacenti.
Negli Stati Uniti nel 2010 è stata approvata la legge Dodd-Frank, i cui obiettivi erano quelli di indurire le regole di solvibilità per le banche, di isolare le attività svolte per conto proprio dagli istituti, di rinforzare i poteri dei regolatori. Ma cinque anni dopo l’ adozione delle nuove norme, grazie al sabotaggio del partito repubblicano, alla scarsa voglia di intervento dei controllori, nonché alla stessa debolezza delle norme, non molto è sostanzialmente cambiato.
In Europa si è fatto comunque comparativamente meno. Ad un certo punto a Bruxelles era stato affidato alla commissione Liikanen uno studio sul cosa fare; l’analisi, pur largamente lacunosa, prevedeva, in qualche modo, la separazione netta tra attività ordinarie e quelle di banca di investimento. La proposta non è passata.
In ogni caso ora il vento nel nostro continente sembra stia cambiando e tutto a favore del sistema bancario. In particolare, mentre ritornano in pieno splendore i processi di cartolarizzazione e il mercato dei derivati, si moltiplicano in Gran Bretagna i segnali di una svolta. È stata ridotta la tassazione su molte operazioni finanziarie. La FCA, l’organismo incaricato del controllo dei mercati, stava incominciando a fare un lavoro positivo, moltiplicando le sanzioni contro gli operatori di borsa e in particolare le banche. Così al suo direttore non verrà rinnovato il contratto ed anche il facente funzioni che voleva seguire la stessa linea verrà mandato a casa. E si potrebbe continuare nell’elenco dei misfatti (Albert, 2016).
Perché in Europa le riforme non vanno avanti
Si possono citare due casi che mostrano chiaramente i meccanismi attraverso i quali i tentativi di riforma del sistema in Europa sono sistematicamente bloccati.
Nel gennaio 2014 Michel Barnier, che era allora il commissario europeo incaricato delle questioni finanziarie, aveva impostato un progetto detto di “separazione bancaria” il cui obiettivo era quello di dividere le attività di mercato da quelle di banca ordinaria. Il progetto avrebbe toccato una trentina di istituti. Ma subito ci fu una levata di scudi, mentre il governatore della banca di Francia lo giudicò uno come schema irresponsabile. Nel frattempo Barnier lascia l’incarico e il nuovo commissario, un britannico, è più molle. Prima sono cancellate dall’elenco le banche britanniche, poi ottengono delle esenzioni la Germania, l’Italia e gli Usa; alla fine il testo è svuotato di quasi ogni sostanza e restano nella rete, al momento, solo tre istituti (Gresillon, 2016).
Intanto la crisi del 2008 aveva dato un nuovo vigore alla vecchia idea di James Tobin per una tassa sulle transazioni finanziarie. I capi di stato e di governo l’avevano approvata al G20 di Cannes del novembre 2011. In Europa 11 paesi si erano dichiarati d’accordo per metterla in atto. Alla fine del dicembre del 2011 la Commissione produceva un progetto che prevedeva una tassazione di una vasta gamma di prodotti finanziari, con l’0,1% di aliquota per le azioni e le obbligazioni e lo 0,01% per i prodotti derivati. La tassa avrebbe potuto fruttare tra i 34 e i 37 miliardi di euro all’anno e avrebbe ridimensionato di circa tre quarti le transazioni sui derivati. Ma la lobby bancaria, agevolata anche dall’opposizione della Gran Bretagna e poi dalla ritirata del governo francese che si allineava sostanzialmente alle posizioni della lobby bancaria, otteneva partita vinta. Sono ancora in corso a Bruxelles le discussioni, ma ci si orienta ormai verso una tassa ad aliquota molto ridotta ed esentando certe transazioni, mentre la sua applicazione è rimandata sino al 2017.
Così si può alla fine affermare che l’Europa si sta muovendo verso un’ulteriore espansione della sfera finanziaria a scapito dell’economia reale (Baranes, 2015).
2.continua
Leggi qui la prima puntata dell’inchiesta
Testi citati nell’articolo
-Albert E., « 2016, année de la contre-attaque de la City, Le Monde, 13 gennaio 2016
-Baranes A., La finanza al potere e l’Europa contromano, www.sbilanciamoci.info, 12 dicembre 2015
-Chocron V., Suppressions de postes massives dans les grandes banques européennes, www.lesechos.fr, 31 dicembre 2015
-Gapper J., Europe’s banks face a difficult global retreat, www.ft.com, 21 ottobre 2015
-Gresillon G., Dix petits nègres au pays de la banque, www.lesechos.fr, 4 gennaio 2016
-Jorion P., Sept ans après, les banques fragiles et impunies, Le Monde, 18 dicembre 2015
-Noonan L., Regulatory changes force investment banks into « capital light » acrivities, www.ft.com, 13 dicembre 2015
-Reed J., We were wrong about universal banking, www.ft.com, 11 novembre 2015




