Intervista a Giacomo Corneo, docente di economia politica a Berlino sul suo ultimo libro “Is capitalism obsolete?” sui sistemi economici alternativi, la crisi del Welfare state e la riformabili del capitalismo.
Nel suo ultimo libro, Why not socialism?, il filosofo Marxista Gerald A. Cohen ha scritto: “il problema fondamentale del movimento socialista è che non sappiamo come far funzionare una società socialista. Il nostro problema non è il presunto egoismo degli esseri umani, ma l’assenza di una tecnologia organizzativa adeguata”. L’analisi rigorosa, ma accessibile, dei principali modelli di società alternative al capitalismo proposti, o realizzati, nel corso della storia – da Platone a Tommaso Moro, Kropotkin, e le economie pianificate fino ad arrivare al reddito di cittadinanza e al socialismo di mercato – occupa gran parte dell’ultimo libro di Giacomo Corneo, Bessere Welt, pubblicato in tedesco presso Goldegg Verlag e tradotto in inglese, francese e giapponese (il titolo inglese è Is capitalism obsolete? per i tipi di Harvard University Press). Il libro si chiude con una proposta dettagliata e innovativa di riforme economiche ed istituzionali per traghettare le economie contemporanee oltre il sistema capitalista. Allievo di Giorgio Lunghini, Corneo è professore di economia politica presso la Freie Universität a Berlino e direttore del “Journal of Economics”. È un esperto di scienza delle finanze e partecipa regolarmente al dibattito di politica economica in Germania. In ambito accademico è noto per avere calcolato la diseguaglianza dei redditi sull’intero arco di vita ed averne dimostrato un aumento secolare in Germania.
Nel 2019 il capitalismo sembra l’unico sistema economico all’orizzonte e i principali movimenti di critica dello status quo sembrano avere un segno prevalentemente regressivo. Perché un libro sulle utopie e le alternative di sinistra al capitalismo proprio ora?
L’aspirazione ad andare oltre il capitalismo è a mio parere ben più diffusa dei rigurgiti nazionalisti e xenofobi così tanto in evidenza di questi tempi. Questa domanda di alternative di sinistra rimane tuttavia largamente latente perché non sa articolarsi concettualmente in termini di un progetto di ampio respiro che sia coerente e credibile. E la critica diventa sterile quando continua a ripetersi senza offrire un tale progetto. Il mio libro vuole contribuire a delineare un progetto tecnicamente solido di un’alternativa al capitalismo, dando così la possibilità a quell’anelito di superamento di esprimersi in maniera costruttiva.
Come è noto Karl Marx non ha descritto in dettaglio le caratteristiche e le istituzioni di una società socialista, o comunista, rifiutandosi di “prescrivere ricette … per la trattoria dell’avvenire”. Questo punto di vista è stato a lungo maggioritario nel movimento socialista. Quali sono i limiti di questo approccio?
Quando non si hanno che le catene da perdere, un salto nel buio può essere preferibile allo status quo. Ma oggi, soprattutto nei Paesi europei, lo Stato sociale, la contrattazione collettiva e i diritti forniscono un punto di partenza storicamente “alto” che la stragrande maggioranza della popolazione non è disposta a mettere a rischio in cambio di vaghe promesse messianiche. Occorre allora riflettere sulla creazione di nuove istituzioni a partire dall’assetto esistente; istituzioni che abbiano in sé il potenziale di superare la logica di dominio capitalista, che risultino comprensibili e appetibili per gli avventori della trattoria di oggi, e che permettano di sperimentare senza il rischio di enormi costi nel caso che tali nuove istituzioni richiedano grosse modifiche, compreso il loro eventuale smantellamento.
Nell’analisi dei vari modelli di economia proposti, o attuati, nella storia, lei usa il capitalismo come metro di paragone fondamentale considerando, da economista, criteri di efficienza e di equità, ma anche l’interazione tra la sfera economica e quella politica, e gli effetti del sistema economico su incentivi, motivazioni e norme sociali. Qual è il vantaggio di questo approccio?
Per il tipo di questione sistemica a cui mi interesso, era necessario non limitarsi al tipico approccio da economista che analizza le conseguenze di politiche alternative in termini di efficienza e distribuzione. La sfera politica e il tessuto sociale, con i loro valori e norme, rispondono alle dinamiche risultanti dal sistema economico e, in effetti, gran parte della critica al capitalismo è critica alla politica e società prodotte dal capitalismo. Era pertanto necessario ragionare sui modelli alternativi in termini più ampi di quelli strettamente economici, avvalendomi dei contributi a ciò più utili offerti da varie discipline cugine dell’economia.
Uno dei principali vantaggi del capitalismo, scrive, sta nella sua capacità di promuovere l’innovazione tecnologica, a differenza per esempio delle economie pianificate. E tuttavia si possono nutrire dubbi sul rapporto tra capitalismo e innovazione. Da un lato c’è la questione della direzione dell’innovazione che nel capitalismo è determinata dalla ricerca del profitto, e non dell’utilità sociale (la ricerca medica è un classico esempio delle possibili distorsioni nell’innovazione). Dall’altro lato una fetta importante di innovazioni tradizionalmente attribuite all’iniziativa imprenditoriale dei singoli sono in realtà prodotto diretto o indiretto della mano pubblica, come ha fatto notare, tra gli altri, Mariana Mazzucato ne “Lo Stato innovatore”.
Non metto in discussione i benefici che un intervento correttivo dello Stato può avere per l’innovazione, ad es. finanziando la ricerca di base e imponendo delle tasse ecologiche quando i benefici privati degli investimenti sono superiori ai benefici sociali. Ma, come spiego nel libro, vi sono degli enormi problemi ad una determinazione puramente politica degli investimenti in ricerca e sviluppo: sia in termini di raccolta ed elaborazione dell’informazione, sia in termini di incentivi di tutte le parti in causa. Sui limiti dell’iniziativa imprenditoriale in fatto di innovazione non ci piove; ma sui limiti dell’innovazione senza imprenditori, nemmeno. Un progetto socialista che abbia senso deve riconoscere il ruolo dell’iniziativa imprenditoriale in merito all’innovazione. Tuttavia non può essere socialista se non estingue il dominio capitalista e ciò richiede che le grandi imprese non siano più in mano ad una élite del denaro ma vengano sottoposte ad un controllo democratico ad esse appropriato. Una questione fondamentale è allora quella del connubio fra la libera iniziativa imprenditoriale e la sua delimitazione al settore delle piccole e medie imprese. Nel libro propongo un meccanismo istituzionale – che prende spunto da quello dell’antidosis usato nell’antica Grecia – che permette di risolvere tale questione.
Secondo la vulgata corrente, il problema principale delle economie pianificate era la difficoltà di raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per poter pianificare l’attività economica dato l’egoismo proprio degli esseri umani. Di contro, nella sua proposta di economia socialista di mercato, John Roemer (“Un futuro per il socialismo”) sostiene che il problema principale delle economie socialiste reali era l’inefficienza della pianificazione come meccanismo di coordinamento della miriade di attività economiche complesse che caratterizzano le società moderne, un ruolo che i mercati svolgono invece egregiamente.
Condivido e si tratta di osservazioni importanti. Affidarsi in certi ambiti al mercato non significa abdicare a favore dell’egoismo individuale e non significa promuovere tale egoismo. Le motivazioni che guidano le persone sui mercati possono essere le più diverse: sono stati ad es. i francescani a sviluppare molti concetti fondamentali per una gestione economica basata sui prezzi e a creare dei fondi finanziari per dare credito a pegno al fine di contrastare la povertà. Il mercato è in alcuni ambiti il migliore meccanismo di coordinamento economico di cui abbiamo conoscenza. Per la società il mercato opera dunque come uno strumento e la proposta di John Roemer dimostra che tale strumento è logicamente compatibile con la proprietà pubblica delle grandi imprese. Questa visione strumentale del mercato è utile anche culturalmente perché dissacra la Grande Istituzione Capitalista dei nostri tempi: il mercato finanziario. Anche quest’ultimo null’altro è che uno strumento che può essere adoperato in modi alternativi per finalità alternative.
Tra le altre proposte, lei analizza il reddito di cittadinanza incondizionato ed esprime un certo scetticismo sulla possibilità che possa costituire il pilastro centrale di una possibile alternativa al capitalismo. Può spiegare perché?
Riassumo brevemente tre ragioni. La prima è di gretta finanza pubblica – il mio pane quotidiano. Affinché il reddito incondizionato emancipi, deve essere di un ammontare tale da permettere, da solo, di superare la soglia di povertà. L’universalizzazione di un tale reddito semplicemente non è finanziabile. La seconda ragione è di ordine etico-sociale. In una società culturalmente ed etnicamente eterogenea il reddito incondizionato può facilmente suscitare reazioni eterogenee, con fasce della popolazione che continuano a lavorare a tempo pieno e grazie alle loro tasse permettono agli oziosi di viverne alle spalle – come gli ebrei ultra-ortodossi in Israele vivono alle spalle dei lavoratori israeliani. La terza ragione afferisce al salto in termini di libertà che si prospetta con la possibilità di vivere tutta la vita senza mai lavorare. Da millenni l’uomo vive nel ritmo del lavoro che ne struttura il tempo. Perciò la libertà dal lavoro deve venire imparata progressivamente. A voler essere ottimisti, il salto da zero a cento potrebbe riuscire giusto ad una minoranza di privilegiati culturali.
Il libro contiene un’analisi dettagliata delle implicazioni di vari sistemi economici dal punto di vista della distribuzione del reddito e della ricchezza. Dedica meno attenzione, invece, alla questione del potere e della sua distribuzione tra classi sociali, non solo nell’agone politico ma anche nella società e nella sfera produttiva. Una radicale modifica dei rapporti di potere sembra tuttavia un obiettivo centrale di progetto di società alternativa, non solo strumentalmente ma anche come valore in sé.
Il nocciolo di tale questione è se, per mantenere il benessere economico attuale, sia necessario concentrare il potere di controllare enormi organizzazioni produttive e finanziarie nelle mani di un ristretto gruppo di persone: le grandi dinastie capitaliste e alcuni top-manager. Se l’analisi proposta nel libro è corretta, tale concentrazione del potere non è necessaria. Si è storicamente determinata ed è in grado di riprodursi nel tempo ma è oggi superflua. Il capitalismo ha portato allo sviluppo di istituzioni quali il mercato azionario e le agenzie pubbliche politicamente indipendenti che possono essere trasformate, capovolgendone le attuali finalità, per esautorare i capitalisti e distribuire in maniera equilibrata il potere che essi oggi esercitano. Credo che questo sia un contributo essenziale del libro: mostrare come istituzioni sofisticate, oggi al sevizio di interessi di una élite al potere, possano essere messe al servizio di un progetto partecipativo ed egalitario.
La questione dei rapporti di potere è centrale anche nell’analisi della fattibilità dei modelli economici alternativi. In assenza di una rottura rivoluzionaria (che nel libro lei non auspica), è legittimo domandarsi se modelli economici alternativi possano esistere e svilupparsi all’interno di un’economia prevalentemente capitalista sufficientemente a lungo da rappresentare un’alternativa credibile. Il lungo declino del Welfare state nelle economie avanzate cominciato alla fine degli anni ‘70 non lascia molto spazio all’ottimismo.
Gli ultimi decenni, di crescita della diseguaglianza e di subalternità culturale della sinistra di governo, dimostrano, parafrasando, che la spinta propulsiva del modello socialdemocratico di Welfare state si è oramai esaurita. Tale modello non riesce neppure a salvaguardare le conquiste che aveva saputo raggiungere nel passato. Proprio da questa crisi nasce l’esigenza di vagliare attentamente le alternative che mettono in discussione la proprietà privata dei mezzi di produzione. Il modello socialdemocratico si basa su una alta e costante quota dei salari nel reddito nazionale e sulla capacità di tassare tali redditi in maniera progressiva per finanziare il Welfare state. Per ragioni strutturali ben note, entrambi i presupposti vengono sempre più a mancare. La redistribuzione deve allora spostarsi al livello dei redditi primari da capitale. Redditi da capitale perché la loro quota nel reddito nazionale tende strutturalmente a crescere. Redditi primari perché la concorrenza fiscale internazionale impedisce un uso forte della tassazione progressiva. Redistribuire a livello dei redditi primari da capitale implica una corrispondente proprietà pubblica di capitale, i cui redditi vengono redistribuiti attraverso il bilancio pubblico. La questione diventa dunque se una gestione pubblica del capitale efficiente e democratica sia possibile e attraverso quali nuove istituzioni.
Come descriverebbe, a grandi linee, le sue proposte di riforme economiche ed istituzionali?
Volendo mettere un’etichetta, il modello proposto è quello di un socialismo “azionario”. Si può pensare a due tappe nell’evoluzione verso tale modello. La prima consiste nella creazione di una proprietà pubblica di capitale senza obiettivi di controllo manageriale delle imprese partecipate. L’istituzione chiave è un fondo sovrano etico che investe in maniera diversificata a livello mondiale e i cui proventi finanziano un dividendo sociale. Investendo in azioni, tale istituzione farebbe partecipare tutti i cittadini agli elevati saggi di rendimento resi possibili dal progresso tecnologico e dalla globalizzazione – saggi di rendimento che oggi sono appannaggio solo dei più ricchi. Il dividendo sociale avrebbe un livello tale da permettere ogni decade di finanziare un anno sabbatico in cui ciascun cittadino può ad es. fare volontariato, politica o riqualificarsi professionalmente. Come già fa la Norvegia, un codice etico potrebbe impedire che il fondo sovrano investa in imprese che inquinano o producono armi nucleari – con un corrispondente effetto di incentivo sulle imprese.
La seconda tappa mira invece a sostituire il controllo capitalistico con un controllo democratico delle grandi imprese. A tal fine è necessaria una seconda istituzione che nel libro chiamo “azionista federale” e che è concepita come un’agenzia pubblica politicamente indipendente. Userebbe delle scalate ostili per acquisire la maggioranza del capitale di imprese relativamente mal gestite e creerebbe nuove imprese in mercati dominati da oligopoli. Le imprese dell’azionista federale verrebbero quotate sul mercato azionario e proprio questo mercato aiuterebbe a monitorarne l’efficienza. All’interno di tali imprese vi sarebbero due differenze fondamentali rispetto alle imprese capitaliste. Primo, la società civile, rappresentata da sindacati, associazioni dei consumatori e di protezione dell’ambiente, sarebbe presente in tali imprese con speciali diritti di informazione per accertarsi che siano veramente rispettate tutte le meravigliose regolamentazioni che abbiamo in questi campi. Secondo, l’azionista federale promuoverebbe la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali mediante meccanismi che ricalcano quelli della co-determinazione in Germania. Grazie ad una selezione accurata dei modi di partecipazione dei lavoratori sarebbe possibile generare aumenti di produttività che farebbero delle imprese dell’azionista federale dei temibili concorrenti delle imprese capitaliste. A lungo andare, l’esito di tale concorrenza determinerebbe l’importanza relativa della proprietà pubblica nel settore delle grandi imprese. Più le imprese dell’azionista federale sono efficienti, tanto più si riduce il ruolo e il potere della classe capitalista.
Lei scrive: “Il nostro viaggio [attraverso vari sistemi economici] conferma che non è sufficiente protestare per l’inefficienza, l’ingiustizia e l’alienazione prodotte dal capitalismo. La vera sfida è indicare una prospettiva convincente di un’alternativa superiore al sistema attuale”. Alla luce della situazione politica attuale, verrebbe da dire che la vera sfida in realtà è l’individuazione e la mobilitazione di un agente collettivo del cambiamento, un blocco sociale si sarebbe detto un tempo. C’è un rapporto tra la definizione di una chiara alternativa superiore al capitalismo e la nascita di un agente collettivo? Qual è il blocco sociale che potrebbe fare propria una proposta come la sua?
La mia esperienza è che le idee che ho prima riassunto in termini di socialismo azionario abbiano una capacità aggregante notevole, nel senso che trovano sostenitori in persone che per posizione sociale e politica sono alquanto distanti. I benefici in termini di dividendo sociale e di partecipazione democratica hanno un’attrattiva universale; inoltre, la classe media, i professionisti e i piccoli imprenditori non devono confrontarsi con la minaccia di nuove o maggiori imposte. Più che il reperimento di un blocco sociale, mi preoccupa la questione degli incentivi che convincano dei soggetti politici appropriati a portare queste proposte di riforma istituzionale nell’arena del discorso pubblico a tutti i suoi livelli, nel territorio, le associazioni, i partiti, i parlamenti.
Il libro si apre, e si chiude, con un dialogo tra un padre e una figlia. Ci sono delle differenze generazionali nei confronti del capitalismo e della ricerca di modelli alternativi?
Senza dubbio il peso delle ideologie del Novecento è molto meno presente nei giovani e questo li fa più ricettivi a visioni come quella del socialismo azionario che non sono dogmaticamente legate ai vecchi schemi. E nei giovani sta l’avvenire.
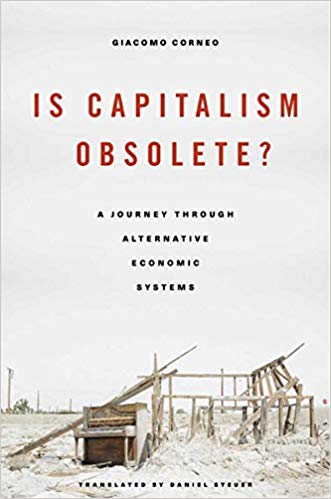
(in parte pubblicata su il Manifesto del 14 febbraio 2019)




