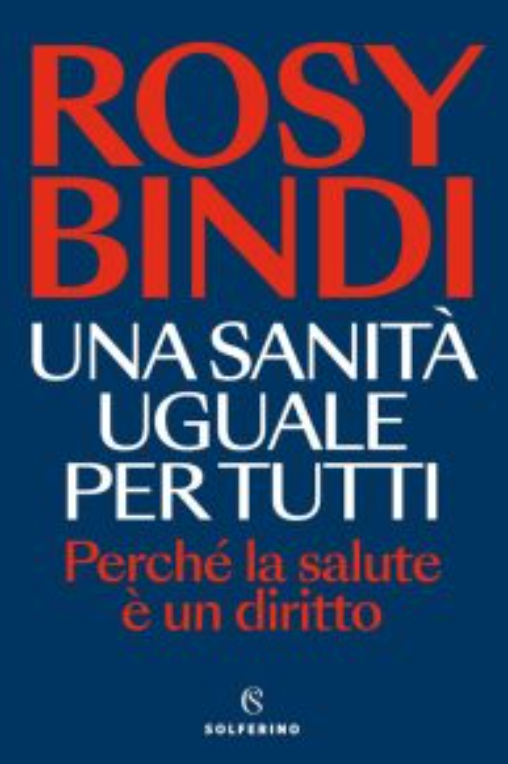L’ultimo libro di Rosy Bindi – “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto” – riesce a tenere insieme la convinta riaffermazione dei principi di uguaglianza, solidarietà ed equità con l’analisi dei problemi che minano il diritto universale alla salute e indeboliscono l’unico strumento capace di rendere effettivo ed esigibile tale diritto.
La salute è una questione centrale per la vita delle persone, per la società e la politica; ma la sanità pubblica italiana attraversa tempi molto difficili, stretta nella morsa di una crisi che colpisce uno dei capisaldi di giustizia sociale del nostro paese, il Servizio sanitario nazionale (Ssn). L’ultimo libro di Rosy Bindi, Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto (con la collaborazione di Chiara Rinaldini, Solferino, 2025), si muove su questa tensione, riuscendo con grande lucidità, passione e nitidezza nell’esposizione a tenere insieme la convinta riaffermazione dei principi di uguaglianza, solidarietà, ed equità con l’analisi dei problemi che oggi minano il diritto universale alla salute e indeboliscono l’unico strumento capace di rendere effettivo ed esigibile tale diritto. A fronte delle tante narrazioni circolanti tese a propugnare l’irreversibilità della crisi della sanità pubblica, la sua presunta insostenibilità e il ricorso a modelli individualistici e assicurativi, così come a logiche di mercato, il volume di Bindi rappresenta un appiglio di grande importanza per rilanciare il Ssn, la sua vitalità ed efficace funzionamento, offrendo risposte e soluzioni alla crisi in corso.
La posta in gioco è molto alta: la priorità che spetta alla salute in un contesto democratico è infatti quanto qualifica il modello di società, di politica e di relazioni umane che vogliamo. Non a caso, la lente attraverso cui Bindi analizza le vicende della sanità è quella del nesso che esiste fra diritti sociali, libertà civili e beni comuni. E, non a caso, la crisi attuale della sanità viene affrontata facendo i conti con i processi che hanno nel tempo messo in discussione le grandi conquiste sociali del passato, in specie del decennio trasformativo degli anni Settanta, con le difficoltà attraversate dall’assetto democratico italiano e internazionale, con gli scenari attuali. Questi ultimi segnati da guerre, politiche di riarmo, ricorso a strumenti di dominio e violenza, paradigmi individualistici e competitivi, logiche di profitto. In questa prospettiva, non solo Bindi offre una visione sistemica del modello di cura e di sanità pubblica, ma anche riscatta questo tema dal suo ambito specialistico e settoriale, ponendolo al centro delle prossime scelte politiche, di un più ampio e profondo cambiamento che coinvolge la collettività nel suo insieme e al contempo singolarmente ciascuna persona.
Il messaggio è chiaro: «la salvaguardia della sanità pubblica è una responsabilità di tutti. Ciascuno di noi deve sentirsi parte del Servizio sanitario nazionale per il quale può fare molto». Dai politici, al personale sanitario, agli amministratori, alle associazioni, ai cittadini in prima persona «che devono diventare più consapevoli nelle scelte che influenzano la salute». La rassegnazione non può essere il sentimento dominante, né l’accettazione di soluzioni che incoraggiano modelli individualistici e corporativi e che conducono all’accentuazione delle disuguaglianze e dei divari territoriali. La sanità ha bisogno di molta politica, ossia di responsabilità della politica intesa «come governo della cosa pubblica, come tutela dell’interesse generale». Tornano alla mente le illuminanti parole di uno dei più importanti oncologi europei, Lorenzo Tomatis, che nei primi anni Novanta scriveva: «Uno si può chiedere se le risorse per la salute siano inevitabilmente e irrimediabilmente scarse oppure se tale scarsità sia una scelta politica». La scelta è quindi sempre politica, scrive Bindi, poiché «si tratta di decidere se si governa nell’interesse generale per promuovere i diritti fondamentali di tutti, italiani e stranieri compresi, o se si favoriscono gli interessi di pochi». È questo il portato stesso della nostra Costituzione, del progetto di emancipazione sociale e personale profilato dai suoi principi, in primis quello di uguaglianza sostanziale espresso nell’articolo 3, 2 comma.
La salute e la sanità sono caratterizzate da una sorta di paradosso. Da un lato, la chiarezza del principio di promozione e tutela della salute universale, come diritto sociale e di libertà garantito a tutti e tutte nel senso più estensivo possibile, diritto individuale e collettivo. Dall’altro, la complessità dell’assetto istituzionale, delle modalità di organizzazione, finanziamento, erogazione dei servizi di cura. Il volume serve a far luce su entrambi questi aspetti e sulle tensioni generatesi nel corso del tempo tra l’esigibilità, l’inalienabilità e l’irrinunciabilità del diritto fondamentale alla salute e le modifiche subentrate a partire dall’affermazione delle politiche neoliberali e dal nuovo protagonismo di organismi economici (dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario internazionale) nelle scelte sanitarie internazionali. La privatizzazione delle attività e dei servizi pubblici per la salute, l’introduzione di logiche di mercato e profitto in ambiti tradizionalmente regolati dallo Stato sociale, le esternalizzazioni di funzioni pubbliche fondamentali a soggetti privati, modelli aziendali e di concorrenza hanno comportato un grave arretramento del diritto alla salute e dei diritti sociali, derubricati a merci comprate sul mercato da quanti hanno capacità di spesa e di reddito.Il volume affronta allora i vari passaggi di questo processo, dopo aver ripercorso i momenti salienti e i principi alla base del Ssn istituito nel dicembre 1978: universalità, equità, globalità di assistenza, partecipazione democratica, finanziamento tramite la fiscalità progressiva generale.
L’intento del libro è anche quello di riportare alla luce i principali aspetti della riforma promossa da Bindi alla fine del secolo scorso (Dlgs 229/1999), nel suo operato di ministro della Sanità dal 1996-2000, in un momento storico di forte scontro sulla sanità. A fronte degli attacchi che già allora provennero da più parti, delle reiterate critiche e della confusione che ancora circola in merito alla riforma voluta da Bindi – ostacolata, accantonata e svuotata di più aspetti dai primi anni del Duemila con i governi a guida berlusconiana – è utile tornare sui suoi aspetti principali, distinguere quanto risale alla precedente controriforma del 1992 e quanto, viceversa, venne perseguito da Bindi. Fu con il decreto legislativo introdotto dal ministro liberale Francesco De Lorenzo (Dlgs 502) che si introdussero profonde modifiche al giovane Ssn, già messo in difficoltà dai primi anni Ottanta con scelte politiche che iniziavano a fare delle priorità economiche e dei vincoli di bilancio il loro asse di riferimento.
Tre le nuove direzioni intraprese nel ‘92: aziendalizzazione, regionalizzazione del servizio, introduzione di forme di assistenza indiretta.
- L’aziendalizzazione trasformò le Usl da strutture operative dei Comuni ad aziende controllate dalle Regioni, organizzate secondo i criteri del nuovo managerialismo, espressione di un modello organizzativo di natura tecnico-aziendalista in luogo del precedente di tipo rappresentativo. Con l’introduzione di una separazione fra la responsabilità della produzione dei servizi e quella del loro finanziamento, i soggetti privati vennero formalmente integrati nel funzionamento del servizio sanitario pubblico e si introdussero logiche di mercato nell’ambito della produzione dei servizi.
- La regionalizzazione potenziò il ruolo organizzativo e finanziario delle Regioni, che ebbero la possibilità di adottare modelli organizzativi sanitari differenziati tra di loro.
- La privatizzazione riguardò la possibilità per le Regioni di avviare in via sperimentale “Forme di assistenza differenziate” per alcune tipologie di prestazioni a pagamento, erogate da mutue professionali, aziendali, volontarie o assicurazioni private.
La costruzione del modello lombardo fu di fatto l’applicazione di questi orientamenti,con l’allargamento delle attività private e della concorrenza tra fornitori pubblici e privati a favore di questi ultimi, la cancellazione della rete dei servizi territoriali pubblici, le esternalizzazioni dei servizi, la marginalizzazione della programmazione pubblica. Tale modello, alimentato da una forte ideologia regionalista competitiva, ha continuato a rafforzarsi. Anche l’introduzione della libera professione intramoenia risale alla controriforma del 1992, che ha aperto il capitolo del suo esercizio nelle strutture convenzionate, come nelle cliniche private.
Di segno opposto furono gli orientamenti della riforma correttiva promossa da Bindi, volta a recuperare gli elementi costitutivi del Ssn, cancellando le principali anomalie del provvedimento del 1992, a riaffermare una centralità politica della sanità pubblica, a contrastare una privatizzazione passiva del Ssn e un “federalismo da abbandono” che ne stava compromettendo l’unitarietà frammentandolo in tanti servizi sanitari regionali. Tra i punti fermi della riforma del 1999: il rilancio del Distretto sanitario e dell’integrazione socio-sanitaria a livello territoriale; l’introduzione del regime di esclusività per i medici del Ssn, nel segno dell’incompatibilità tra il lavoro nel servizio pubblico e quella nelle cliniche private; la regolazione trasparente dei rapporti tra le strutture pubbliche e quelle private. E ancora, vale la pena di ricordarlo nelle difficoltà che attraversa la tutela della salute mentale, quanto delineato nel Progetto omonimo, compresa la chiusura degli ultimi manicomi e la riorganizzazione dei servizi di cura e assistenza territoriali.
Richiamare questi aspetti è oggi necessario, alla luce dello scenario che va prefigurandosi. A farsi strada è infatti un sistema composto da una sanità pubblica, sempre più impoverita e indebolita e a cui si lasciano peraltro le attività più costose, e parallelamente da un “secondo pilastro” privato accessibile solo ai più ricchi o alle categorie di lavoratori che rientrano nel welfare aziendale con una forte gerarchizzazione delle coperture e dei servizi offerti. La realtà del “secondo pilastro”, incoraggiata da più parti al fine di compensare il sottofinanziamento del servizio pubblico, si basa sul ruolo crescente assunto dalle assicurazioni private e dai fondi integrativi. Questi ultimi sono divenuti largamente sostitutivi – lontani dalla realtà dei “fondi Doc” presenti nella normativa del 1999 e finalizzati a potenziare l’erogazione di prestazioni e trattamenti non compresi nei Lea –, sostenuti da crescenti agevolazioni fiscali, discutibili dal punto di vista dell’equità e dell’efficienza. Parallelamente alla diminuzione delle risorse economiche assegnate alla sanità pubblica, aumentano quelle per la sanità privata concentrata in grandi gruppi di imprese, di cui il volume dà conto, in continua espansione e con fatturati sempre maggiori. Cresce, al contempo, la spesa privata diretta (l’out of pocket) con tutte le conseguenze evidenti nella rinuncia alle cure di coloro, circa 6 milioni di persone, che non possono permettersi di pagare di tasca propria queste ultime. Mentre – suggerisce Bindi – una corretta, equa e progressiva politica fiscale potrebbe risolvere molti problemi rispetto alla reperibilità di adeguate risorse per i servizi di welfare.
Articolo pubblicato anche da Salute Internazionale