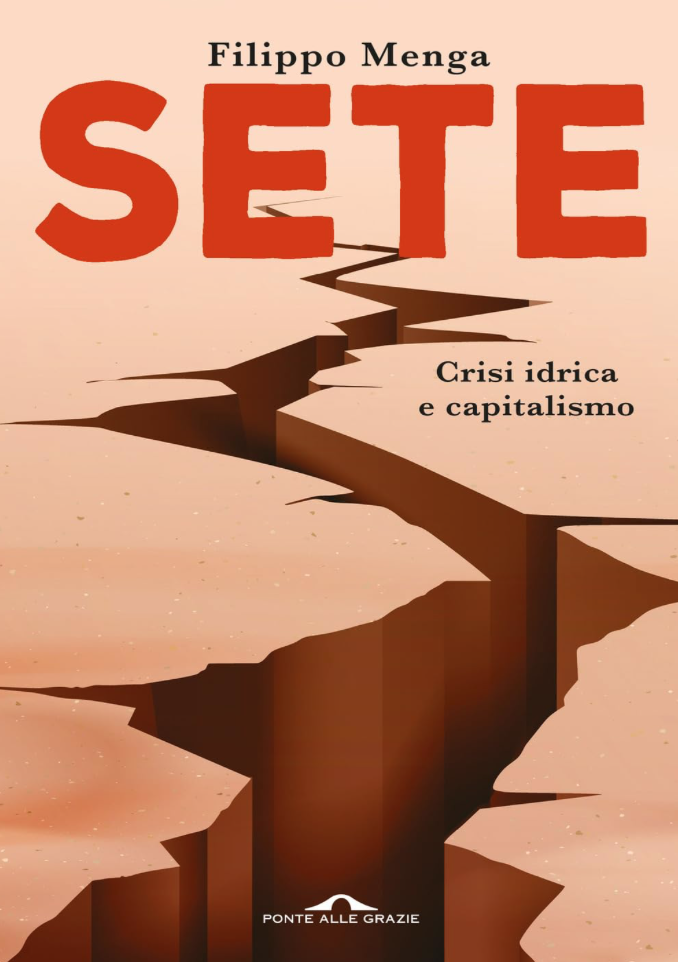Stiamo vivendo in una crisi idrica globale. Di cosa si tratta esattamente? Quali, le cause e soprattutto, quali le possibili soluzioni? Il libro ‘Sete’ di Filippo Menga più che fornire risposte ci invita a interrogarci sulle soluzioni troppo spesso proposte come universali ed evidenti, e offre una chiave di lettura per interpretare la relazione tra […]
‘Sete’ ci parla dell’acqua come lente attraverso cui interpretare e spiegare le contraddizioni insite nel sistema sociale, politico ed economico del nostro tempo: “Parlare di crisi idrica nel ventunesimo secolo non è molto diverso dal parlare dello stato del capitalismo nel ventunesimo secolo” (p.25). Il libro, divulgativo, scritto dal geografo Filippo Menga, basato su anni di ricerche sul tema, fornisce una chiave di lettura per interpretare la relazione tra crisi idrica e capitalismo, visto come una struttura globale. In effetti, l’acqua è sempre più al centro di negoziazioni internazionali e forum sovranazionali: basti pensare alla conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a New York nel 2023. E’ stato il primo evento ONU interamente dedicato all’acqua negli ultimi 50 anni (l’ultimo si era tenuto a Mar de Plata nel 1977) e ha visto la partecipazione di attori statali e non statali, con l’obiettivo di trovare soluzioni alla crisi idrica globale – proprio quella che Menga affronta nel suo libro. O ancora, quest’anno l’Unione Europea ha pubblicato una ‘strategia per la resilienza idrica’, ‘European Water Resilience Strategy’, la cui pubblicazione arriva dopo anni di politicizzazione del tema acqua a livello europeo, sia da parte di associazioni che hanno lottato per il riconoscimento dell’acqua come diritto umano, che di gruppi di industriali che vedono l’acqua come una risorsa sempre più scarsa e allo stesso tempo fondamentale per i processi produttivi.
In questo contesto, il libro di Filippo Menga offre un contributo puntuale e di grande attualità nel comprendere le dinamiche di governance transnazionale dell’acqua – nelle sue problematiche, contraddizioni e disuguaglianze.
Il libro si compone di quattro capitoli (oltre all’introduzione e alla conclusione), analizzando prima a livello teorico l’origine e le contraddizioni del concetto di ‘crisi idrica globale’ (capitolo 1) e poi soffermandosi su alcuni casi empirici di proposte di soluzioni a tale crisi, ad esempio quelle ad opera di grandi organizzazioni benefiche come Water.org e WaterAid (capitolo 2), le campagne di sensibilizzazione delle celebrità come Matt Damon (capitolo 3) e infine le iniziative di responsabilità sociale d’impresa di Nestle Water (capitolo 4). Sulla scia del lavoro intellettuale del filosofo Walter Benjamin, Menga legge il capitalismo come religione e sostiene che esso si sia appropriato di concetti chiave come cura, sacrificio e redenzione, manipolandoli – ad esempio nel caso della crisi idrica: la cura come espressione del filantrocapitalismo, il sacrificio individuale delle celebrità per ispirare quello delle persone comuni, e la redenzione cercata da una delle principali aziende globali coinvolte nell’accaparramento dell’acqua.
Il libro apporta contributi significativi a diversi campi disciplinari, e a diversi dibattiti scientifici e di attualità; per questa recensione però mi soffermo su due nodi centrali dell’argomentazione.
Il principale punto di forza del libro, a mio avviso, consiste nel problematizzare – e, in ultima analisi, decostruire – l’idea che esista una singola e universale ‘crisi idrica globale’ omogenea attraverso territori e classi sociali. Il volume mostra in modo convincente che non esiste una crisi idrica, ma molteplici crisi idriche che sono non globali ma innanzitutto locali. L’analisi evidenzia inoltre che, sebbene la nozione di ‘crisi’ evochi una condizione eccezionale e temporanea, il termine è stato impiegato negli ultimi cinquant’anni per descrivere fenomeni che sono in realtà strutturali e sistemici. Infine, il libro illustra come l’universalizzazione dell’idea di crisi idrica globale finisca per depoliticizzarla, offuscandone i rapporti di potere e le disuguaglianze socio-ambientali.
In relazione alla natura della crisi idrica (globale), l’autore ne discute anche le possibili soluzioni, e si dedica a demistificarne le onnipresenti soluzioni individuali (e individualiste), mostrando come una crisi strutturale non possa necessariamente essere affrontata attraverso solamente azioni individuali ma richieda azione collettiva. L’argomentazione è svolta attraverso l’analisi delle contraddizioni insite nell’azione delle grandi organizzazioni benefiche come Water.org e WaterAid, delle campagne di sensibilizzazione delle celebrità e delle iniziative di sostenibilità di una della più controverse multinazionali legate al consumo di acqua, Nestle Water. In ciascuno di questi casi, l’autore mostra che le iniziative per promuovere l’accesso all’acqua e per ‘risolvere’ la crisi idrica sono, allo stesso tempo, sintomo e causa di tale crisi e finiscono per alimentarla.
Per quanto riguarda il superamento delle visioni individualistiche di soluzione alla crisi, un aspetto che, per quanto menzionato nel libro, potrebbe essere ulteriormente approfondito è quello del ruolo e dell’azione, già esistente, di attori collettivi che si sono mobilitati in relazione all’acqua. E’ proprio grazie all’ azione collettiva che l’acqua è stata riconosciuta come diritto umano dalle Nazioni Unite nel 2010, e pochi anni dopo dall’Unione Europea grazie all’iniziativa dei cittadini europei Right2Water (diritto all’acqua), che è stata la prima del suo genere ad avere successo.
Questo è tanto più rilevante nel contesto italiano, dove c’è stata una mobilitazione di massa contro la privatizzazione dell’acqua nei primo decennio del ventunesimo secolo, portando ad un referendum sul tema, con esito positivo, nel 2011. Anche in anni più recenti, il tema dell’acqua viene politicizzato da movimenti e organizzazioni ambientaliste, come centrale nella crisi ecologica in cui stiamo vivendo. Un altro aspetto che potrebbe essere approfondito, a partire dal libro, è la differenza nel ruolo di diverse organizzazioni nel costruire l’architettura della governance globale dell’acqua. In sintesi, ho offerto alcuni spunti di riflessione, nello spirito che il libro apra un dibattito piuttosto che chiuderlo – in quanto si offre come un assai necessario intervento nel considerare l’acqua essenzialmente sociale e politica, a fronte di visioni esclusivamente ingegneristiche e tecniche che tuttavia ancora popolano il dibattito pubblico.
In conclusione, la lettura è vivamente consigliata a chiunque sia interessato ad approfondire una delle tematiche del nostro tempo – il collegamento tra crisi ecologica e capitalismo, visto attraverso la lente dell’acqua.