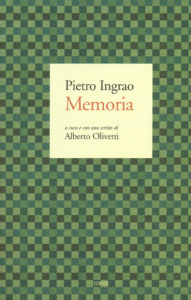Fra le carte lasciate da Pietro Ingrao, Alberto Olivetti e Maria Luisa Boccia hanno trovato un manoscritto intitolato “Memoria”, appena pubblicato per le edizioni Ediesse. Fra il ritrovamento di questo lavoro e la morte di Ingrao nel 2015 sono passati diversi anni, ma il testo ha il carattere di un bilancio di vita
Fra le carte lasciate da Pietro Ingrao, Alberto Olivetti e Maria Luisa Boccia hanno trovato un manoscritto intitolato “Memoria”, già completo per la pubblicazione che però Ingrao non ha avuto il tempo o l’intenzione di fare. È questo manoscritto che essi hanno deciso di pubblicare oggi per le edizioni Ediesse, con una nota di Alberto Olivetti, ma senza variazioni; fra il ritrovamento di questo lavoro e la morte di Ingrao (2015) sono passati diversi anni, ma il testo ha il carattere di un bilancio di vita. Otto anni prima Ingrao aveva rilasciato una lunga intervista a Nicola Tranfaglia. Il confronto fra i due testi non comporta scoperte: se mai è accresciuta la problematicità, a conferma di una scelta del metodo, decisiva nel dialogo con se stesso, come si fa alla fine di un lungo percorso.
La ricostruzione si dipana in quattordici brevi capitoli, che a loro volta si raggruppano attorno a tre temi: gli anni della formazione; la fase come dirigente del partito; i punti che rimangono irrisolti. Tutto questo in un racconto sciolto ed elegante, nel quale come è suo costume non mette mai l’ingrandimento su se stesso, anzi.
Sugli anni della formazione egli sottolinea soprattutto come essa sia avvenuta, e non solo per lui, nel rapporto con i coetanei, molto più che in quello con la generazione dei padri; e, se vale una più modesta testimonianza (io sono di pochi anni più giovane di lui) quel che scrive vale anche per me, che devo spostare il mio anno decisivo al 1939, quando ormai non c’era quasi più tempo, già la Spagna era stata uno spartiacque, tuttavia per tutti i trent’anni successivi non era stato agevole trovare da chi farci indicare la strada. Erano anni foschi e, se le famiglie non avevano già qualche collegamento era difficile non trovare gli azionisti o i comunisti, quelli di cui più si sussurrava. Ricordo anzi una ingenerosa insofferenza di quindicenne per “i grandi” che non avevano abbastanza parlato, lasciando noi giovanissimi senz’armi. Ingrao annota invece una messa a punto importante che riguarda la generazione formatasi negli anni ’30, la quale annusava da tutti pertugi quel che filtrava della grande cultura: e io, che non abitavo a Lenola ma a Venezia e poi Milano, avevo potuto fiutare i grandi russi (diffusi chissà perché liberamente da Ettore Lo Gatto) e, oltre che Pirandello, Ibsen. Semmai, della Spagna andrebbe indicato – e fra gli appunti di Ingrao non si trova – il problema che essa pose al Partito comunista italiano, che si trovò a decidere in modo pesante e, credo, imperdonabile, all’interno della sinistra. Per parte mia, se ebbi dei dubbi, non li sviluppai e mi sarei ben guardata dall’affidarmi all’Omaggio alla Catalogna di Orwell, del quale da brava comunista diffidavo. Almeno in Memoria, Ingrao non ne parla proprio.
Più vasto e problematico è il secondo blocco su cui si articola il suo scritto. Anzitutto perché comprende gli anni della prima maturità (va dai trent’anni alla fine della vita e si intreccia con la storia del Partito comunista del quale Ingrao diventa presto un dirigente di prima grandezza).
Esso va dall’esperienza, prima come capocronista, poi come direttore del quotidiano l’Unità, alla quale il Pci lo chiama, e che egli sottolinea come essenziale di quel “dilatarsi del politico” che considera proprio del Pci e particolarmente la parte meno discutibile di Togliatti. E anche la prima esperienza del rapporto con l’Urss, dove in quegli anni imperversa Zdanov: nel suo corso incontrammo la condanna del Politecnico di Vittorini e di Studi filosofici di Antonio Banfi, il primo accusato di cosmopolitismo e il secondo di aver difeso Sartre da un attacco di Kanapa del Pcf, e poco dopo ci fu la requisitoria di Togliatti contro i pittori; Ingrao non ricorda certi episodi disastrosi per la cultura del dopoguerra, in particolare la messa in guardia contro tutta la cultura anglosassone (il suo riferimento è più che Pavese, Emilio Cecchi). Vittorini chiuderà poco dopo il Politecnico, dopo un estremo tentativo di salvataggio e non senza uno scontro personale acerbo con Togliatti, e Banfi chiuderà fino al cinquantasette la sua rivista, non so che cosa Pietro allora ne pensasse; forse rimandò il tempo dello scontro a undici anni dopo, quando sarebbe stato (pensava) più forte. Lo scontro si poteva già allora prevedere durissimo; in mezzo fra quel dopoguerra e l’undicesimo congresso del partito sta il cinquantasei di Krusciov, cioè la prima condanna dello stalinismo. Neanche di essa e della sua sommarietà, della quale aveva fatto cenno Concetto Marchesi al decimo congresso del partito, Memoria si occupa; esse debbono essere inglobate nella ripetuta condanna alla legnosità di metodo e linguaggio propria dei comunisti di quegli anni, Pci incluso malgrado il suo modo di procedere sia stato meno pesante di quello di altri partiti, in particolare il Partito comunista francese, con il quale rimase per un tempo una polemica sotto traccia. Peccato, perché sarebbe stato interessante avere una riflessione di Ingrao su quel che deriva per la cultura italiana da quel lungo silenzio e dall’ossequio al grande alleato, un poco simile a un iracondo maestro-padrone: silenzio e alleanza, dai quali pensiamo di esserci, come si usa dire, sdoganati con la pubblicazione di Gramsci, la cui presenza va oltre la questione delle culture di tutto il movimento comunista, investendo storia e politica ma che, nello specifico delle culture appartiene a un altro dopoguerra. In verità c’è da chiedersi, al di là di quel che costò al quasi quarantenne Ingrao l’undicesimo congresso, si può immaginare quanto gli sia costata l’adesione, anche se non esplicita, a uno stile di comunista che ci legava tutti, ma al quale ci sentivamo vincolati da una specie di luciferina adesione, come deve succedere in alcuni ordini religiosi. Ricordo me stessa che strapazzavo Anna Maria Ortese, sia pure in privato, perché, invitata dal settimanale L’Europeo a fare un viaggio-inchiesta nell’Urss, ne aveva scritto, con il suo acuto senso della povertà e del dolore, molte pagine spietate. Non dubitavo che dicesse il vero ma pensavo che non si dovesse dirlo: finimmo con l’abbracciarci piangendo, ma andò così, e c’era in me, comunista, una sorta di orgoglio masochista. Insomma, c’era in noi un “sapere di più”, anche dolente, ma non inconsapevole, per cui fummo in qualche misura complici dello stalinismo (e non giova ricordare che erano anche anni terribili di attacco cui eravamo sottoposti). Di Pietro Ingrao ricordo che al mio dirgli della situazione dell’est, di cui venivo a sapere di più, obiettava: “le cose sono più complicate” e mi azzittiva, e io capivo.
Più densa la fase seguente, che porterà Ingrao e la sua Memoria fino alle domande sulla crisi del comunismo: è una fase che in verità investe oltre mezzo secolo e avviluppa tutta la sua esperienza di dirigente-militante. Insomma, mi viene da chiedermi di che parlavano, quali pertugi frequentavano i ragazzi degli anni quaranta? O si contentavano dei pertugi consentiti, perché il Partito comunista italiano ne permetteva più di altri partiti. Ricordo Luporini che confessava ad Althusser: “forse siamo stati un po’ puttane”, alludendo appunto a quel regime di semilibertà che ci consentivano e che faceva sì che nei primi sessanta, in un viaggio che facemmo in Ungheria, lo storico Ragionieri intonasse canzoni anarchiche toscane in modo provocatorio dalla mattina alla sera. Pietro Ingrao era certo il più integro, quella che nella “Memoria” definisce la sua natura lenta, era anche un’alta e non pieghevole moralità interiore, che il partito dei più semplici avvertiva e guidava un accento e una verità a lui particolare.
La solitudine e l’isolamento che patì per aver difeso una posizione che la dirigenza del Pci non accettava, penso che fossero dovuti anche al fatto che quel che lo divideva dagli altri allora (siamo nel 1966, all’undicesimo congresso del partito) riguardava da vicino le scelte da compiere in Italia. Eravamo alle soglie del centrosinistra e sarebbe l’ora di riconoscere che la maggior parte del gruppo dirigente, Togliatti incluso, fece un errore di ingenuità e insieme di alterigia su quel che avveniva, come se il cadere dell’ostracismo democristiano nei confronti dei socialisti comportasse anche il riconoscimento che sarebbe occorso prima o poi aprire al partito comunista, cosa che non avvenne mai. Ingrao per la verità non si fece, credo, questa illusione, lavorò invece sui dubbi e le possibilità di un certo riformismo che presso alcuni governanti pareva farsi strada. Non penso a Moro, sul quale Pietro Ingrao, come scrive, conta forse più di quanto il personaggio, cautissimo, non consentisse, avendo le idee sin troppo chiare sul suo partito, che infatti lo lasciò cadere quando (è mia persuasione) il suo partito avrebbe forse potuto salvarlo concedendo la libertà a un detenuto minore, salvo affrontare quel che ne sarebbe conseguito (lo aveva capito Giuliano Vassalli e del resto la Dc concesse ben altro qualche anno dopo trattando per Cirillo). Quanto alla chiusura delle Camere decisa da Ingrao, non vedo che altro abbia fatto se non impedire di parlare da uno scranno istituzionale a Bettino Craxi: si dirà che non la meritava.
Per quel che può valere in questa sede va rilevato che Ingrao aveva tentato, più e oltre che di liberare il dibattito all’interno del partito, di tentare sul serio una grande politica attorno a quel “modello di sviluppo”, termine che poi non avrebbe amato, ma il cui senso era chiaro, e che Amendola irrideva, dicendo di preferir “soldi”, anzi “soldoni subito”, con l’aria di andare diversamente dal compagno accusato di intellettualismo sul popolare e concreto. La sconfitta di Ingrao significa non solo rinuncia alla libertà del dibattito interno, che per breve tempo pareva aver impegnato perfino Longo, ma il formarsi dell’asse politico del partito (la famosa linea) come riconoscimento e assunzione della complessità del reale, tema fondamentale, come ricorda nella nota conclusiva Alberto Olivetti. Il Pci non l’accettò mai, gran parte dei presenti a quel congresso, anche fra gli “ingraiani” considerarono che assumere questo problema sarebbe stato indebolirsi.
Al contrario, di là sarebbe passato lo snaturamento della natura del Pci, al quale Ingrao non consentì mai, presentando al congresso di Rimini, che sarebbe sopravvenuto poco tempo dopo, una sua mozione che non riuscì a essere maggioritaria. Vale forse la pena di ricordare che nella discussione del 1965, i più disertarono, tanto era pericoloso affrontare anche da lontano quel tema. Si preferì isolare Ingrao, che da parte sua interdì a noi giovani, che avremmo voluto farlo, di intervenire nel merito. Egli non consentì mai a quelli che considerava suoi seguaci o che in qualche modo gli erano legati, di partecipare alle sue battaglie: probabilmente per difender loro o forse anche per difendersi dall’accusa di essere un leader di frazione, tema che peraltro affrontò esplicitamente in altra sede. Di questo Memoria non parla, essa termina con una nota di Olivetti sulla cognitività del metodo, garantita appunto dalla capacità di cogliere e di dar voce alla molteplicità e processualità del soggetto, processo costitutivo del conoscere. Su questo Ingrao non si sofferma, forse perché pensa che sia implicito, come effettivamente è, in tutti i suoi scritti. A riflettere su alcuni cenni che “Memoria” più volte rapidamente abbozza, il problema aperto non mi pare quello del carattere legnoso, spesso francamente insopportabile del linguaggio comunista, ma se sia pensabile una rivoluzione senza guasti insanabili. Si può sostenere che una rivoluzione è sempre immatura, anche se ne esistono quelle che chiamiamo le “condizioni oggettive”.
La verità è, se mai, che ogni rivoluzione (in senso proprio) cioè ogni rottura del metodo processuale e dialogico comporta a sua volta un pericolo involutivo, come Ingrao dice nei suoi versi sulla torre e la polvere e negli inquieti versi che seguono (pericolo che la rivoluzione francese avvertì già nella fase che precede la Convenzione). Ma è evidente che rinunciando alla proposta di Ingrao il Pci accelerò la sua crisi, distruggendo i mezzi per farvi fronte, come forse sarebbe stato possibile.
Forse Ingrao condanna il leninismo del 1917, ma non si azzarda a dire che allora sarebbe stato possibile aprire un dialogo con l’autocrazia; in verità un’autocrazia non lo consente per definizione. Il problema vero è se una rivoluzione non sia sempre, sotto questo profilo immatura, senza autorizzarsi a concludere “allora, sarebbe stato meglio non tentarla, o che fosse perdente”. Ingrao certo non lo fa, e non so davvero se lo avrebbe sostenuto. Forse il problema effettivo è che ogni rivoluzione deve domandarsi come metter fine a se stessa, come instaurare le basi di una convivenza democratica, pena andare incontro a una rovina nel medio termine; su questo Ingrao non ci illumina, e come avrebbe potuto senza infilarsi lui stesso nella “pasticceria dell’avvenire di marxiana memoria”?
In ogni caso, c’è da essere grati a Maria Luisa Boccia e a Alberto Olivetti per averci messo a disposizione questo manoscritto che getta luce su quello che è stato il percorso da militante di Pietro Ingrao e di averci fornito quindi i materiali per ogni riflessione sul futuro del nostro paese; non che ci siano le condizioni di una rivoluzione; ma ci sono quelle, molto pericolose, di una involuzione della quale già vediamo i segni in alcune forze politiche, e che già si è sviluppata pericolosamente in Polonia e in Ungheria, e ha messo radici nelle forze di destra fascistizzanti della Germania e dell’Austria. C’è da chiedersi se il problema che Gramsci si pose nel 1929 non si ponga anche per noi adesso; come risulterà il 5 marzo e resterà completamente aperto qualche giorno dopo. E dunque qualche soluzione andrà proposta.
Pietro Ingrao, Memoria, Ediesse, 2017