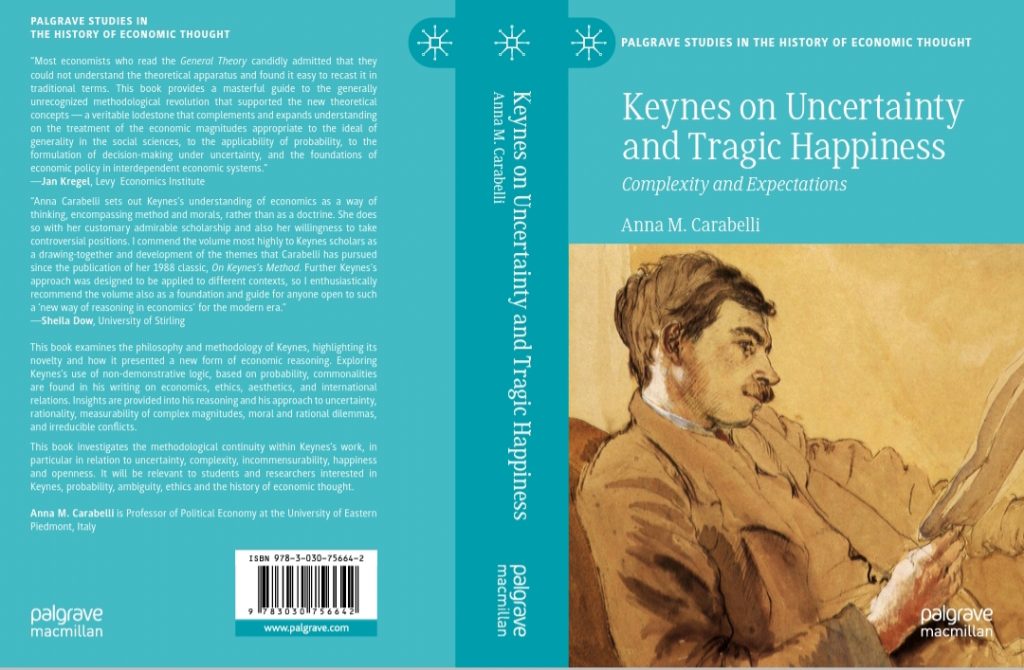Per fare chiarezza sull’aggettivo “keynesiano” applicato alle recenti politiche post Covid, è utile la lettura del libro di Anna Carabelli, fresco di pubblicazione e frutto di 40 anni di studio.
Nell’ultimo decennio di una lunga crisi economico-finanziaria sfociata in quella economico-sanitaria del Covid-19 le risposte della politica economica si sono colorate in senso “keynesiano”. La crescita della spesa pubblica (negli Stati Uniti e più recentemente anche in Europa) e la gestione della liquidità a livello globale si sono svincolate dai dettami “classici” per affrontare pragmaticamente (forse temporaneamente) le instabilità che minacciano gli equilibri locali e globali.
La qualificazione di “keynesiani” attribuita a tali interventi riflette l’interpretazione riduttiva degli anni Cinquanta e Sessanta secondo la quale la proposta di politica economica che scaturiva dalla lettura della General Theory riguardava esclusivamente situazioni di carenze di domanda per cui gli interventi fiscali e monetari avevano la funzione di tappare i momentanei buchi di un tessuto economico che di norma procedeva spontaneamente nella sua piena efficienza.
Tuttavia l’aggettivo keynesiano è stato messo in discussione da lungo tempo per la sua mancata corrispondenza con la “visione” del processo economico attribuibile al pensiero di Keynes. Una lettura più coerente delle idee di Keynes – e a una gestione delle politiche ad esse più propria -, si può avvantaggiare del recente contributo di Anna Carabelli, Keynes on uncertainty and tragic happiness. Complexity and expectations, Palgrave Studies in The History of Economic Thought, 2021, nel quale l’autrice espone i risultati «di oltre quarant’anni della sua ricerca sul “metodo di Keynes” a dimostrazione che l’aspetto innovativo, e la ricchezza propositiva, del suo contributo non è riducibile ad alcuni aspetti, analitici e di prassi politica, ma va individuato nel suo contenuto metodologico. Un’interpretazione – sviluppata nel libro con riferimenti a tutti gli scritti di Keynes – non convenzionale in quanto solo economica, essa è anche «filosofica, logica, etica, estetica e basata sul ruolo della religione». Opponendosi alle interpretazioni predominanti, l’autrice sostiene che per Keynes «la teoria economica non fornisce un corpo di conclusioni definitive immediatamente applicabili alla politica [ma essa è] un metodo, piuttosto che una dottrina, che aiuta il suo possessore a trarre conclusioni corrette», specie in quelle situazioni che implicano “scelte tragiche”, delle quali la recente alternativa tra salute e reddito ci fornisce un’immediata esemplificazione.
Per illustrare l’importanza che l’autrice attribuisce all’aspetto metodologico è utile partire dal merito, ovvero dal modo in cui Keynes affronta la questione dell’ordine monetario internazionale, trattata nell’ultimo capitolo del libro, prima delle conclusioni.
L’approccio di Keynes alle relazioni internazionali si fonda sulla critica del gold standard che se, in alcune circostanze storiche, ha svolto una funzione di stimolo sul commercio internazionale e la crescita delle economie nazionali, in altre, tutt’altro che rare, è risultato un fattore di squilibrio tanto da costituire una gabbia che ha vincolato l’azione dei singoli paesi. Un tale sistema monetario non ha impedito infatti che pressioni mercantiliste di singole nazioni – che non sono compensabili all’interno di una gestione rigida della moneta internazionale – abbiano generato, attraverso la “paura delle merci” e la “ricerca di liquidità”, una situazione deflazionistica generalizzata. L’interdipendenza organica tra le nazioni all’interno dell’economia globale impedisce che si possa interpretare tale situazione con un’analisi riduzionista: l’esito complessivo (la situazione globale) non è riducibile alla somma delle parti (le situazioni nazionali). Il rifiuto di Keynes ad accettare un sistema istituzionale in cui una moneta neutrale sarebbe in grado di garantire contemporaneamente sviluppo del commercio internazionale e piena occupazione nazionale, è fondato sull’argomentazione che, in un mondo di realtà nazionali eterogenee, il perseguimento razionale degli interessi particolari (nazionali) si traduce, a livello di sistema e quindi di benessere generale, in un gioco a somma negativa: ordine esterno e ordine interno risultano in conflitto. Un’analisi della situazione deve essere tale da evitare le “fallacie compositive” tipiche dell’analisi riduzionista; nel caso specifico che la costruzione di un ordine mondiale impostato sulla disciplina di mercato sia l’altare sul quale venga sacrificato il diritto al proprio policy space nazionale.
L’approccio di Keynes alle relazioni internazionali si fonda sul diritto delle differenti realtà nazionali a gestire la propria economia e a «proteggere il proprio contratto sociale» con politiche macroeconomiche appropriate all’obiettivo; ma ciò richiede un contesto analitico dalla causalità invertita: non è l’aggancio della moneta interna all’oro (alla moneta internazionale) a garantire la piena occupazione, ma è la possibilità di salvaguardare l’occupazione che permette un aggancio stabile all’oro (e la stabilità dell’ordine internazionale). A tale fine occorre una “gestione internazionale” che agevoli il compito dei singoli governi: «i paesi devono operare all’interno di un quadro di istituzioni internazionali pianificate e gestite per il bene comune». L’interdipendenza organica di realtà eterogenee richiede una «capacità di governo lungimirante» [parole di Keynes] in grado di ampliare «lo spettro di paesi disposti a partecipare all’adeguamento a un mondo più equilibrato».
Tutti gli approcci di Keynes alle relazioni internazionali (dal 1913 al 1945, pur modulati per tener conto delle contingenze storiche) sollecitano un sistema di “azioni concertate” tra paesi in grado di realizzare il necessario, non meccanico, «compromesso sostenibile tra le esigenze disciplinari del sistema (internazionale) e quelle autonomistiche degli stati membri». Si tratta, come ricorda Anna Carabelli, della «politica “due volte benedetta” [parole di Keynes] di riprendere il controllo sul tasso di interesse, in base al quale i paesi potrebbero raggiungere e mantenere la piena occupazione e, allo stesso tempo, aiutare i loro vicini a raggiungere questo stesso risultato».
Le istituzioni contano per governare l’eterogeneità del reale; contano non come meccanismo neutrale rispetto alle relazioni di mercato, ma come correttivo di queste ultime. Vi è la necessità di correggere la spontaneità del mercato; vi è la necessità di «un vero e proprio macro-manager globale». A questo riguardo, nell’approccio di Keynes gli esempi non mancano: il Piano di stabilizzazione dei prezzi delle materie prime; l’introduzione di “controlli sui capitali” per preservarli dalla spinta all’uniformazione esercitata dagli investitori internazionali; la possibilità di fissare i tassi di interesse senza interferenze indesiderate dall’esterno; l’esigenza di una moneta che permetta alle nazioni del continente europeo di tornare a farsi credito a vicenda; l’International Clearing Union per creare riserve sufficienti da soddisfare le esigenze del commercio internazionale distribuendo gli oneri sia sui paesi in deficit che su quelli in surplus; la cancellazione del debito (inter-alleato), quale prerequisito per l’avvio di un piano di “responsabilità condivise”.
Ne risulta rovesciata la spiegazione tradizionale. Di fronte al “disordine internazionale”, al conflitto tra disciplina internazionale e autonomia nazionale, la visione di Keynes è che l’autonomia della politica economica interna risulta essere la causa e non l’effetto dell’ordine internazionale (e ciò dovrebbe valere anche per l’euro). Prefigurando una realtà “non naturale”, prospetta l’inevitabilità di un conflitto irriducibile (il “tragico” richiamato nel titolo del libro) tra interessi particolari delle nazioni dominanti e interesse generale della comunità globale; un conflitto la cui soluzione richiede una scelta etica; per queste ragioni di «filosofia e metodo» Anna Carabelli può qualificare l’economia politica di Keynes come una scienza “morale”.
Se l’analisi di Keynes dell’ordine internazionale porta a concludere, contrariamente al pensiero dominante, che la stabilità dei rapporti monetari internazionali è la conseguenza e non la causa della stabilità delle economie nazionali, è evidente che la differenza tra le due argomentazioni, entrambe logicamente strutturate, non può derivare che dai fondamenti radicalmente diversi su cui sono fondate; da un modo diverso di “guardare” il mondo. Ha ragione quindi l’autrice nel ricercare nel metodo di analisi le strutture che permettono all’economista inglese di fornire una visione teorica e una politica economica del tutto alternative a quella delle sintesi neoclassiche. I concetti utilizzati da Keynes nel suo approccio alle relazioni internazionale – quelli di eterogeneità dei soggetti, di interdipendenza organica tra le parti, di complessità di sistema così come la visione olistica del processo economico e l’incombenza delle scelte tragiche – non sono elementi decorativi introdotti ad hoc per arricchire l’analisi, ma elementi essenziali per la costruzione della sua argomentazione, della sua struttura analitica. Un quadro metodologico non episodico che si viene costruendo lungo l’intero suo percorso scientifico, dal contributo iniziale di A Treatise on Probability a quello maturo della General Theory.
La tesi è di grande interesse ed è merito di Anna Carabelli di porla in discussione in tutti i suoi complessi risvolti. Il punto fermo dal quale procede l’autrice è che, per Keynes, «l’economia è una branca della logica, un modo di pensare, piuttosto che una scienza pseudo-naturale»; è «una scienza morale nella misura in cui si occupa di valori etici e di introspezione» e non può essere ridotta «a una macchina o a un metodo di manipolazione cieca, in grado di fornire una risposta infallibile, ma ci dota di un metodo organizzato e ordinato per pensare a problemi particolari». È con questo riferimento che l’autrice ricostruisce l’impronta metodologica del contributo di Keynes all’economia; della cui peculiare architettura possiamo qui fornire solo alcuni cenni sui punti principali.
Il libro fornisce, nella sua prima parte (capp. 2-4), i fondamenti peculiari del pensiero di Keynes secondo la sua logica del probabile sottolineando l’assoluta divergenza con i fondamenti della teoria neoclassica. I successivi tre capitoli (capp. 5-7) si concentrano sulle implicazioni che il suo “modo di pensare” ha per la politica economica, con un accento particolare sull’esistenza dei dilemmi “tragici” (tra ragioni eterogenee, opposte e ammissibili), per la cui soluzione la sensibilità morale e l’imperativo etico devono integrare il ragionamento economico.
La questione preliminare è che nella trattazione teorica di Keynes non si può prescindere dal fatto che ignoranza e incertezza caratterizzano il contesto in cui operano gli individui economici. Entrambe dipendono dai limiti della conoscenza umana: «l’ignoranza è mancanza di ragioni note, anche parziali [per cui] non esistono probabilità o, se esistono, non sono conoscibili, per incapacità di ragionamento, [mentre] l’incertezza […] è l’incommensurabilità intrinseca di formulare la probabilità, cioè l’impossibilità teorica di dire se due probabilità sono uguali o disuguali».
Le proposizioni riguardanti la realtà economica devono quindi essere in grado di trattare il rischio, la precarietà, l’errore e, di conseguenza, non possono che essere probabilistiche. La necessità di fare i conti con un mondo aperto all’indeterminatezza, ma anche alla libertà umana, spiega perché Anna Carabelli consideri la logica del probabile di Keynes (del suo A Treatise on Probability) la struttura analitica fondante sia della sua costruzione teorica che del suo interventismo politico. Ciò significa riconoscere che le argomentazioni in economia sono approssimazioni alla verità, un’acquisizione provvisoria di risultati, che necessitano di una verifica continua al fine di restringere lo spazio del dubbio, anche se la maggiore conoscenza solleva ulteriori dubbi e genera nuovi problemi (secondo quella che può essere «l’interpretazione di Keynes come seguace dell’approccio realist common-sense di Thomas Reid e G.E. Moore, dell’uso del linguaggio quotidiano»).
Una tale impostazione ha una serie di implicazioni analitiche. Innanzitutto, il funzionamento dell’economia non può essere spiegata da meccanismi fondati su una razionalità astratta (risolta dal mercato), ma dal formarsi di “credenze ragionevoli” che, formulate sulla base di conoscenze teoriche e di fatti della realtà, forniscono – con un certo grado di probabilità e relativo grado di fiducia – una spiegazione del comportamento probabile dei (singoli e diversi) soggetti economici e un’indicazione delle prescrizioni (sempre probabili) sull’opportunità di modificare la loro azione. La conoscenza economica discende, per effetto di questa logica del probabile, dalle informazioni disponibili ricavate dalle percezioni, dall’esperienza, dalla memoria e dai molteplici altri canali individuali e sociali che, selezionati, divengono i “conoscenze” rilevanti dell’argomentazione. Essi dipendono dal “materiale” che la realtà storicamente offre e, a questo riguardo, ampia è l’analisi nel libro della complessità e della commensurabilità delle informazioni rilevanti per l’analisi economica: «questo materiale è non omogeneo, non divisibile in parti omogenee uguali e indipendenti, non finito, non chiuso, ed è caratterizzato dall’interdipendenza organica (parziale o totale)». Inoltre questo materiale è “complesso o molteplice” per il variare, al mutare delle circostanze, delle sue «qualità […] in direzioni diverse dando origine a ordini crescenti e decrescenti». Ancora, è possibile che, in determinate situazioni, non sia possibile far ricorso a un’unità comune per misurare le probabilità di eventi provenienti da una realtà eterogenea: «l’incommensurabilità intrinseca della probabilità deriva dalla natura delle ragioni e dei motivi della probabilità logica e non da irregolarità statistiche empiriche». La realtà di Keynes risulta del tutto incompatibile con l’assunto di omogeneità (dell’utilità e della produttività) che sta alla base della teoria neoclassica.
Spiegati i comportamenti “probabili” dei diversi soggetti rilevanti, il discorso è tutt’altro che chiuso; nelle parole di Keynes «dopo aver raggiunto una conclusione provvisoria isolando uno per uno i fattori complicati, dobbiamo poi tornare indietro per considerare, nel miglior modo possibile, le probabili interazioni dei fattori tra di loro». Un processo che nulla ha a che vedere con l’equilibrio generale walrasiano, poiché la relazione tra le parti e il tutto [che, per Keynes è la caratteristica di tutti i problemi monetari] «è caratterizzata da interdipendenza organica». È questa interdipendenza che è di ostacolo all’introduzione, quantunque tacita, di qualsiasi forma di riduzionismo (la macroeconomia non è l’immagine della microeconomia) ed è il riferimento che permette di analizzare le “fallacie di compositive” nelle quali incappa il riduzionismo neoclassico. La contrapposizione di metodo si presenta peraltro in modo drastico quando si riconosca la necessità della teoria neoclassica di ricorrere a precise “assunzioni tacite” per garantire le proprie conclusioni sull’esistenza del suo “equilibrio naturale”: le aspettative a lungo termine normalmente si realizzano; l’offerta crea di norma la propria domanda; il risparmio si traduce in investimento a un tasso d’interesse normale. Assunti a priori che non sono necessari nel metodo di Keynes che non richiede, impone, alcun tasso (di disoccupazione o di interesse) “naturale”. Anna Carabelli è pertanto autorizzata ad affermare come le «metafore organiche sull’insieme e sulle sue parti, e sulle fallacie compositive, siano il manifesto retorico del suo metodo» è a rivendicare alla General Theory la qualifica di “generale” proprio per il fatto che la sua analisi si muove in uno spazio più ampio di quello delimitato dalle “assunzioni tacite” classiche.
La teoria economica come argomentazione probabile è quindi il modo per trattare la complessità del materiale economico e le sue modificazioni al cambiamento delle circostanze. Ma è proprio questa complessità che induce Keynes a ritenere che una «teoria ragionevole ci dà solo “qualche motivo per credere”» e, in presenza di una realtà complessa e mutevole, a diffidare della matematizzazione dell’economia (inopportuna, «salvo in pochi casi molto limitati che sono logicamente irrilevanti per la macroeconomia») quale guida delle decisioni umane. Non a caso «preferisce il discorso ordinario per evitare errori logici e una falsa aria di precisione: è meglio avere ragione approssimativamente che sbagliare esattamente». Dunque più che la razionalità è da perseguire la ragionevolezza, ovvero il risultato di un giudizio autonomo, libero e ragionato, fondato su evidenze e sulla fiducia nel giudizio stesso. La logica probabile fornisce questa ragionevolezza, come testimonia la stessa General Theory vista come «un esercizio di persuasione, che offre agli economisti ragioni per modificare le loro credenze ragionevoli».
Al ragionamento come sviluppo delle ipotesi (o delle possibilità), si associa indissolubilmente l’azione come verifica della spiegazione e rettifica dell’esperienza. Il modo di argomentare è infatti il medesimo sia per il teorico che per il policy maker; il comportamento del politico economico è infatti il frutto dell’elaborazione delle conoscenze a lui disponibili tra le quali anche i risultati della strategia adottata, nella continua revisione delle proprie conoscenze e nella rivalutazione del peso da attribuire alle probabilità di successo delle proprie scelte.
Un processo che non offre alcuna soluzione “certa”, ma è “aperto” in più direzioni, più o meno prevedibili a seconda delle contingenze storiche. Esso ha una connotazione drammatica in quelle situazioni che Anna Carabelli definisce “dilemmi, morali o razionali, tragici”; ovvero in quei contesti «di indecisione, di conflitto irriducibile in cui esigenze o ragioni morali (alcune esigenze o ragioni per essere precisi) non possono essere pesate l’una contro l’altra […] usando una comune unità di misura omogenea»; sono contesti in cui la decisione è stretta in un dominio di doveri e obblighi inerentemente contradditori per cui qualsiasi scelta venga fatta lascia il decisore con il senso di colpa di aver comunque mancato a un dovere morale. L’importanza che l’autrice attribuisce a questi dilemmi è che essi sono tutt’altro che rari in economia, anche se la “scienza triste” le occulta attribuendo una oggettività economica “ragionata” alla scelta tra le eventuali alternative (disoccupazione-inflazione, crescita-disuguaglianza, svalutazione-salari, occupazione-debito pubblico, sanità-produzione e l’elenco potrebbe continuare). La loro soluzione richiede “giustizia” poiché, nel conflitto tra interessi (individuali e collettivi) divergenti, «né la Provvidenza né la mano invisibile smithiana interviene per comporli ».
La considerazione dell’esistenza di “dilemmi tragici” ha anche implicazioni analitiche. Se essi devono trovare una soluzione all’interno dello scenario morale di un’epoca e di una cultura data, i comportamenti della teoria non possono prescindere dal quadro delle decisioni politiche. La scienza economica è un’“economia politica”, dove l’analisi tiene conto «dell’indecisione e dell’oscillazione del giudizio» che dipende dai valori, dalle norme dichiarate, dalle figure di riferimento che, a livello della società, sono connessi culturalmente da assunti e da regole sociali, anche implicite e informali. L’economia e la politica economica non possono sfuggire al «problema della retta condotta o del dovere morale»; l’etica e l’estetica, per quanto non suscettibili di una traduzione quantitativa, contano per i comportamenti dei soggetti e per le scelte della politica attraverso le immagini che sintetizzano l’insieme di tanti e diversi valori che circolano nella società e che danno luogo a altrettanto narrazioni diffuse sul futuro della stessa. Senza mai dimenticare che la politica economica non è senza influenza sul peso delle esperienze di vita e quindi sullo stesso scenario morale dell’epoca. È per questo che l’economia politica va considerata, come ribadisce Anna Carabelli, una “scienza morale”, non riducibile a tecnica, le cui argomentazioni più che all’esattezza devono aspirare alla ragionevolezza. E ciò si ricollega all’inizio di questo scritto, alla ragionevolezza che devono caratterizzare le istituzioni pubbliche e quindi alle riflessioni di Keynes sull’organizzazione del sistema monetario internazionale.
Per quanto rapida e parziale, la presente sintesi dovrebbe essere sufficiente per ritenere fondata la convinzione di Anna Carabelli che Keynes trae «rigorosamente la sua economia […] dalla sua filosofia, dalla sua logica non dimostrativa, dalla sua etica come etica della virtù, dalla sua felicità come eudaimonia tragica aristotelica»; che il suo contributo all’economia politica non consiste in qualche correzione-integrazione “keynesiana” del modello neoclassico per meglio interpretare i suoi squilibri di breve periodo, ma prospetta un modo radicalmente diverso di “guardare il mondo”, di rappresentarlo, di modificarlo.
Per chi non ritiene che la visione economica dominante disponga delle risposte adeguate ai problemi “tragici” della nostra epoca, il materiale offerto da Anna Carabelli offre un’opportuna (e ritengo necessaria) occasione di riflessione e promozione di un dibattito. Sono persuaso della tesi da lei sostenuta, in maniera convinta e convincente, che, nonostante le molteplici forme (neo e post) assunte dai diversi “keynesismi”, una rivoluzione metodologica dell’economia politica che abbia le radici nel pensiero di Keynes non c’è ancora stata, o almeno non in una forma compiuta e sufficientemente diffusa nella nostra professione di economisti; che sia importante riflettere sul metodo di Keynes in quanto «non è solo un economista [ma] un logico, un filosofo, un filosofo della misura, uno scienziato morale» che si propone di dimostrare che «l’economia e il denaro sono solo mezzi materiali e condizioni preliminari per raggiungere il bene e la felicità [dove] la felicità non è conforto; ma felicità tragica (bene e dolore insieme)».