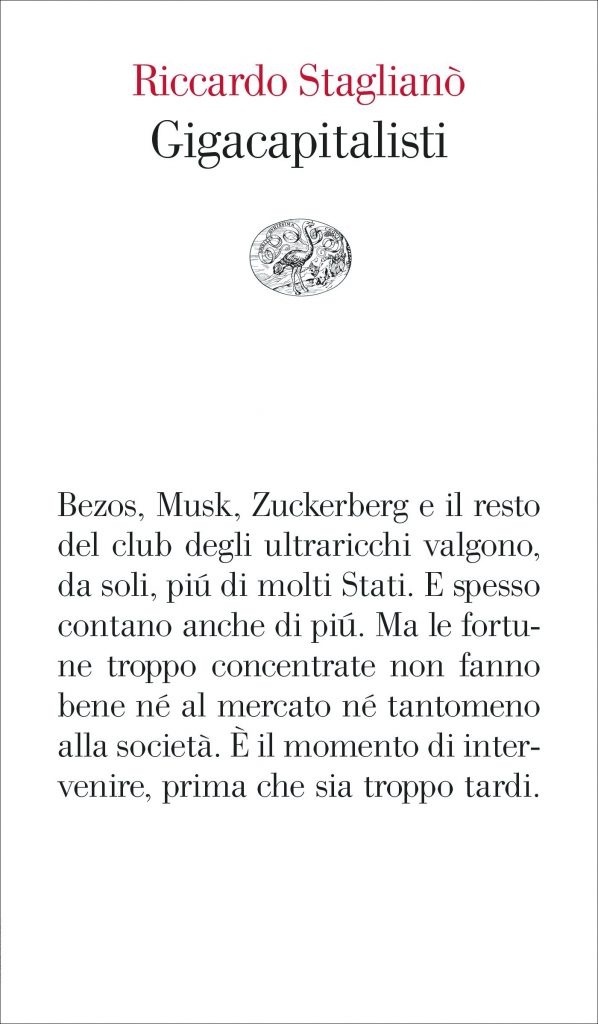Durante la pandemia Jeff Bezos ha aggiunto 80 miliardi di dollari al suo patrimonio. Elon Musk l’ha poi superato come uomo piú ricco al mondo. La nazione virtuale da due miliardi di utenti fondato da Mark Zuckerberg, se fosse reale, sarebbe la più popolosa al mondo. Sono i “Gigacapitalisti” descritti da Riccardo Staglianò nel suo […]
Durante la pandemia Jeff Bezos ha aggiunto un’ottantina di miliardi di dollari al suo patrimonio. Elon Musk l’ha poi superato come uomo piú ricco al mondo. La nazione virtuale da due miliardi di utenti fondato da Mark Zuckerberg, se fosse reale, sarebbe la più popolosa al mondo. Sono i Gigacapitalisti descritti da Riccardo Staglianò nel suo libro (Einaudi, pag. 152, e.12). Il cui denaro dà loro un potere che, un tempo, competeva solo agli Stati sovrani. Per limitarlo servono tasse giuste, leggi migliori, più diritti ai lavoratori e una nuova consapevolezza collettiva. Eccone una anticipazione.
A distanza di tempo il ricordo più vivido che ho della passeggiata sulla versione nautica di Versailles è la schiena di una donna. All’apparenza magrebina, china per terra ad appiccicare pezzetti di nastro adesivo azzurro su scalfitture nel parquet di rovere. Guasti che io, pur sforzandomi, non riuscivo a vedere. Lei sì. Il suo mestiere era di individuare i graffi impercettibili nel pavimento patrizio di quella nave da 160 milioni di euro. E poi quelli sui lavandini in travertino, sulle boiserie alle pareti e così via. A bordo anche la più piccola imperfezione era bandita. Lei doveva denunciarla, appiccicandoci sopra un nastro adesivo blu, e qualche specialista sarebbe intervenuto per sanarla. Mentre camminavo con soprascarpe di gomma per non peggiorare la situazione mi sono chiesto quanto guadagnasse per quel lavoro parossistico e ho provato a immaginarmi che casa avesse lei e quanta acribia potesse permettersi nella sua manutenzione. Milleduecento euro, il suo stipendio mensile, era quanto quella sontuosa abitazione marina consumava di cherosene in mezza giornata per tenere accese le luci. Lo sapeva? Ci pensava mai? E che effetto le faceva questa pantagruelica sproporzione? Centosessanta milioni di euro. Fermatevi un attimo a pensare. In equivalenze al tempo del Covid significano mascherine per tutta l’Africa o prime dosi Astrazeneca per quasi 90 milioni di esseri umani. (…)
Una ricchezza pericolosa (per la democrazia)
La parabola nautica, con i suoi record di business pandemico, serviva solo come location (dove piazzare i nostri eroi) e metafora (dell’andamento strepitosamente anticiclico dei loro portafogli). Ciò che proverò a fare, nelle pagine che seguiranno, è abbozzare un identikit dei campioni assoluti di questa nuova schiatta di ultra-ricchi. Non per invidia di classe – sono decisamente sazio con i soldi che ho e non trovo niente di male nel fatto che ci siano persone che ne hanno tanti di più – ma perché mi sembra che i patrimoni dei Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg del mondo abbiano raggiunto dimensioni incompatibili con un buon funzionamento della democrazia. Nel senso che quelle spaventose quantità di denaro si traducono inevitabilmente in altrettanto potere. Compreso quello di interferire sulle leggi che decidono ad esempio quante tasse far pagare e a chi (vale la pena rammentare che questi signori hanno tutti almeno due mestieri: il proprio e quello di elusore fiscale). Studiandone le biografie il topos più ricorrente, e storicamente inedito, è che si tratta di privati cittadini in grado di fare cose prima appannaggio solo degli Stati.
Privati come Stati
Gates, come mi ha fatto notare un’amica no green pass al termine di un’intemerata altrimenti piena di fattoidi distorti e sfondoni puri e semplici, se la defezione dell’America minacciata da Trump fosse andata in porto, col suo 10 per cento sarebbe diventato il principale finanziatore dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per dire. Bezos, se i suoi piani continuano a marciare come negli ultimi vent’anni, si candida a diventare l’emporio unico dell’umanità. Prima di Musk nello spazio c’erano andati sono Russia, Stati Uniti e Cina. Oggi questo Creso che sembra ancora scontare i danni del bullismo patito da piccolo è il fornitore ufficiale della Nasa per scarrozzare avanti e indietro i suoi astronauti. Nell’attesa di colonizzare Marte. Infine c’è Zuckerberg di cui sempre più commentatori (e investitori) chiedono la testa per offrirla in pasto alla pubblica opinione scandalizzata dalla serie crescente di rivelazioni su un cinismo aziendale innalzato a forma d’arte. E parliamo di uno che, se la sua creatura fosse una nazione, con quasi tre miliardi di cittadini sarebbe più popolosa della Cina. Con un livello di sorveglianza, sia detto per inciso, che Pechino si sogna. Com’è quindi che, nello spazio di una generazione, questi che chiamerò gigacapitalisti (in ossequio sia al gigayacht da 500 milioni di dollari che Bezos si sta facendo costruire dall’olandese Oceanco e che tutti loro potrebbero largamente permettersi, sia ai gigabyte e ai gigabit, unità di misura del mondo digitale di cui sono a vario titolo campioni), com’è, dicevamo, che sono diventati addirittura più potenti dei loro predecessori dell’inizio del secolo scorso?
Baroni di rapina 2.0
Parlo del gruppo di imprenditori statunitensi che nei cinquant’anni tra il 1865, fine della guerra civile americana, e l’inizio della Prima guerra mondiale, fu largamente responsabile della trasformazione della società in cui operavano da agricola a industriale. E che in quel traghettamento ammassarono anche enormi fortune. (…) Ma al di là del pallottoliere, che pur conta, quali sono similitudini e differenze tra i «baroni di rapina» e i «sultani del silicio» secondo una nomenclatura rilanciata dall’Economist qualche anno fa? Molto, rispondeva il settimanale liberale, economicamente super pro-mercato e politicamente conservatore: «Sono gli Übermenschen degli ultimi 200 anni di capitalismo americano, le persone che sentono il futuro nelle loro ossa, lo fanno accadere e a volte si spingono troppo oltre». Che è già, considerata la fonte, un discreto segnale di allarme. E, come i «malfattori di grande ricchezza» di un tempo, anche questi «nuovi capitalisti stanno perdendo la loro patina» accusati da sempre più fronti di applicare le stesse spudorate strategie di subornare politici, impiegare lavoro precario, danneggiare i concorrenti e soprattutto monopolizzare i mercati perché se «Rockefeller una volta controllava l’80 per cento del petrolio mondiale oggi Google detiene il 90 del mercato delle ricerche in Europa e il 67 negli Stati uniti». Ieri come oggi la «somiglianza che colpisce di più è il fatto di aver rimodellato le basi materiali della civiltà». Leland Stanford e E.H. Harriman stesero oltre 200 mila miglia di binari creando le ferrovie. Andrew Carnegie rimpiazzò il ferro con l’acciaio, reinventando l’edilizia e tutto il resto. Ford inaugurò l’era dell’automobile. Bill Gates ha messo un pc in ogni casa. Larry Page e Sergey Brin li hanno riempiti di tutta la conoscenza del mondo. Mark Zuckerberg ha collegato in una piazza virtuale quasi 3 miliardi di persone. «Come le ferrovie resero possibile per oscure aziende di rivoluzionare dal cibo (Heinz) al bucato (Procter & Gamble), internet consente ad altri imprenditori di rivoluzionare ogni cosa dalle vendite al dettaglio (Amazon) ai trasporti (Uber)». Ieri come oggi il successo ottenuto in un settore ha fatto sviluppare loro un appetito insaziabile anche per quelli vicini. Il solito Rockefeller comprò foreste, creò fabbriche per trasformare il legno in barili, produsse componenti chimici per la raffinazione e mise in piedi flotte di navi e treni per trasportare i suoi prodotti. Jezz Bezos dal commercio in proprio è passato ai server che rendono possibile quello di tutti gli altri, alla robotica che gestisce i magazzini, allo streaming che invoglia sempre più persone ad abbonarsi a Prime e così via. Elon Musk dalle auto elettriche alle batterie, ai pannelli solari per alimentarle. L’edizione 2019 del rapporto della Internet Society ha coniato il termine di «total service environments», ambienti a servizio totale. Ovvero della tendenza delle piattaforme a diventare una destinazione onnicompresiva, espandendosi nel maggior numero di direzioni possibili, offrendo sempre nuovi servizi e contenuti, sia per trattenere gli utenti che aumentare i fatturati.
Chiediamo allo storico
Sebbene l’Economist sia un gran giornale, è pur sempre un giornale. Per il raffronto storico meglio chiedere a uno specialista. Noam Maggor, che insegna alla Queen Mary University of London, è l’autore di Brahmin Capitalism che per i tipi della Harvard University Press ha raccontato l’America industriale della fine del diciannovesimo secolo. Dopo le doverose cautele di rito («Paragoni in epoche diverse sempre difficili») approva il parallelo, che può contribuire «a un’utile conversazione pubblica»: «Allora chi possedeva le ferrovie e il telegrafo decideva i prezzi da praticare agli agricoltori che le usavano per spedire le merci o quelli per far circolare le informazioni. Amazon, Google e Facebook non sono in condizioni tanto diverse». «Discriminazione» era il termine che ricorreva più spesso nelle denunce dei produttori di allora: «Non doveva essere un privato a decidere i vincitori e vinti di quel commercio. All’epoca era chiaro ma poi, fino a oggi, la dottrina antimonopolistica è stata interpretata in chiave di consumer welfare, ovvero di tutela dei consumatori dal rialzo dei prezzi. E lì Amazon ha avuto buon gioco nel dire che con loro i prezzi andavano addirittura giù». I parallelismi proseguono, sul fronte della lotta alla sindacalizzazione, tanto odiata dai robber barons quanto dagli odierni gigacapitalisti. «Ma quella di pensare ai dipendenti di Amazon come a un gruppo circoscritto di una fase temporanea – come Lincoln diceva del lavoro in fabbrica, in attesa che ognuno diventasse imprenditore di se stesso – che non ci riguarda è un errore di prospettiva perché il trattamento di quei lavoratori si riverbererà, come sempre è avvenuto, su tutti gli altri» avverte Maggor. Infine c’è l’attitudine dell’opinione pubblica: i gigacapitalisti sembrano più amati che disprezzati. «Anche Richard Hofstadter, uno degli storici più importanti del secolo scorso, sosteneva la stessa cosa dei robber barons» dice Maggor «ma poi storici successivi hanno mostrato gli scioperi, le marce, la violenza: una storia di conflitti. Quando faccio lezione cito l’esempio di George Pullman, il cui nome è diventato sinonimo di bus, che da un giorno all’altro tagliò del 30 per cento i salari dei suoi dipendenti per fronteggiare una crisi economica lasciando intatti quelli dei manager e quando morì dovettero seppellirlo in una speciale cripta di metallo per paura che venisse riesumato per spregio dagli anarchici. Se Hofstadter leggesse oggi Time che celebra Musk come uomo dell’anno, l’ammirazione dei media mainstream nei confronti dei Gates, Jobs e così via, arriverebbe forse alla stessa conclusione. Ma c’è una corrente di odio che non va sottovalutata. La stessa che Trump, fra tutti i politici possibili, è stato così scaltro da cavalcare quando ha puntato il dito contro Big tech in difesa dell’America manifatturiera. Una rabbia montante che, fino al 1930, fu sottovalutata come oggi. Allora c’è voluto un Franklin Delano Roosevelt per incanalarla, ora non so chi sarà, ma so che è un sentimento che esiste e ha ottime ragioni».
…e cosa dovrebbero avere!
(…) Nel 1911, accogliendo l’iniziativa del dipartimento di giustizia, la corte suprema decretò lo smembramento della Standard Oil in trentaquattro distinte società. John D. Rockefeller si ritirò in silenzio da ogni carica. In una recensione sul New Yorker di An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination di Sheera Frenkel e Cecilia Kang Jill Lepore ricorda il ruolo decisivo della Tarbell nell’aver apparecchiato lo spezzatino di un secolo fa. Le assonanze di oggi con ieri sono vistose. Solo la reazione è diversa. Molto più urbana. Anzi questi gigacapitalisti – sarà che trafficano in merci molto meno sporche di petrolio e acciaio – il più delle volte fanno simpatia. Colpa dell’eterno elemento afrodisiaco del potere, di politici spesso non all’altezza della situazione e di tanti giornalisti – o quanti, che si bevono la retorica siliconvallica di «rendere il mondo un posto migliore» o che di ogni nuovo smartphone non trovano di meglio da dire che è «il migliore di sempre» – che preferiscono vestire i panni dei cheerleader che quelli dei guastafeste. Ecco, tra tanti difetti, almeno quest’ultimo ce lo siamo fatti mancare. E in questo libriccino, che vorrebbe essere una specie di keisaku (il bastoncino che il maestro zen usa per ridestare chi, nella meditazione, si assopisce, pur non essendo io né maestro né tantomeno zen), un keisaku editoriale con cui proviamo a dire: fate attenzione. Perché i nostri concittadini hanno dato prova di essere sin troppo zen rispetto alle mostruose disuguaglianze di cui sono vittime o spettatori ma la loro pazienza – immagino, reputo, spero – non è infinita.