L’autrice indirizza un focus sugli abusi degli uomini sul corpo delle donne nelle aree di conflitto e conduce un’analisi sull’attacco globale ai diritti e alle conquiste delle donne in termini di diritti, salute, istruzione, cura, welfare, nell’ambito del libro “Facciamo Pace” scritto con Altero Frigerio e Roberta Lisi.
La guerra di genere
Jin, Jiyan, Azadî. Donna, vita, libertà: il grido rivoluzionario delle ragazze iraniane. La violenza degli uomini contro le donne, sul corpo delle donne. Un focus sugli abusi nelle aree di conflitto ma anche l’analisi di un attacco globale ai diritti e alle conquiste delle donne in termini di diritti, salute, istruzione, cura, welfare. Autodeterminazione sempre più ad ostacoli, dall’Afghanistan agli Stati Uniti. Vecchie e nuove culture patriarcali si sommano alle varie forme di dominio e sopraffazione, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro fino ai femminicidi, mai così tanti in Italia come nel 2022. L’occhio delle donne contro le armi, l’odio e le discriminazioni, per una cultura del rispetto, del dialogo, della pace.
L’ultima guerra che affrontiamo in queste pagine è quella degli uomini contro le donne, contro il loro corpo. A tutte le latitudini. E “Donna vita libertà”, lo slogan che attraversa e simboleggia la rivolta del popolo iraniano, potrebbe essere usato in molti altri contesti. Ma restiamo in quel Paese. L’annuncio ai primi di dicembre del 2022 dell’abolizione della polizia morale è stato salutato come un passo avanti, mentre sarebbe bastato approfondire la notizia per accorgersi che insieme alla norma sullo scioglimento, quel corpo militare veniva associato ai pasdaran. E’ così aumentato il grado di repressione e l’operazione mirava a dividere la rivolta che invece ha continuato a crescere in intensità e tenuta. Il nostro Paese, diversamente da altri Stati europei, fatica a capire e a sostenere quelle lotta. L’Italia, fatta salva l’indignazione del Presidente Mattarella per le impiccagioni e la violenza perpetrata quotidianamente dal regime degli ayatollah, e qualche dichiarazione di circostanza, ha mostrato un atteggiamento di pressoché totale sottovalutazione di quello che sta succedendo in Iran, ma soprattutto un’evidente incapacità di empatia nei confronti in particolare delle giovani donne iraniane, comunque il cuore della rivolta. A questo dato generale si somma la disattenzione con cui si tratta ciò che riguarda i corpi femminili, pressoché reticenti nell’esprimere la necessaria collera rispetto all’esistenza stessa di una polizia morale.
Si dimostra l’incapacità di cogliere la portata della violenza contro le donne esercitata nei loro confronti in quanto donne. Perché è questo il cuore, il nucleo del ragionamento da approfondire, anche a fronte di un comune atteggiamento di resistenza nel comprendere che proprio di questo si tratta. Un dato mi sembra sempre più evidente: tanto più il pensiero femminista ha individuato lucidamente il tema della violenza verso le donne in quanto donne, più il mondo maschile si è chiuso in un’autodifesa dei comportamenti individuali senza ragionare sui comportamenti collettivi. E senza provare a riflettere sulla necessità, per gli uomini che non esercitano violenza, e non sono pochi, di mobilitarsi.
Su una tematica diversa dalla violenza contro le donne si sarebbe messa in moto la mobilitazione, e provato a discutere, a ragionare sulle cause e a cercare di contrastare comportamenti sbagliati o negativi. Se in un luogo di lavoro si indice lo sciopero degli straordinari e un collega accetta invece lo straordinario, si discute e si prova a riflettere insieme. Se in quello stesso luogo un collega molesta una delle colleghe di lavoro, nel migliore dei casi l’atteggiamento è quello di autoassolversi, affermando comportamenti personali ed individuali di altro tipo.
Ecco il nodo della questione. La violenza contro le donne riguarda tutto e tutti: la vita quotidiana delle famiglie, il mondo dei luoghi di lavoro, le case e le strade, per arrivare al fenomeno dei migranti. La questione della violenza attraversa, è bene ricordarlo, il tema delle torture, tornato di attualità – purtroppo – proprio in Ucraina e poi in Iran. E attraversa tutte le guerre, come quella russo-ucraina o già in Siria, in Libia piuttosto che in altri conflitti. Potremmo dire senza tema di smentita che il memorandum con la Libia, tra le tante negatività ha anche quella di finanziare gli strupri delle migranti. Se approfondissimo quanto accade in Myanmar ritroveremmo esattamente le stesse situazioni. E’ così incistato in tutta la possibile gamma dei comportamenti e degli avvenimenti che riguardano le persone che è davvero impensabile e inaccettabile come non si provi ad affrontarlo partendo dagli autori. Non c’è dubbio che le responsabilità penali sono del singolo che commette gli abusi, ma manca un giudizio morale che interroghi le popolazioni.
Anche lo stupro è stato ed è usato come un’arma di guerra. Ne sono piene le cronache di qualunque guerra. Questo però parla di nuovo dei corpi. Le guerre comportano sempre massacri e brutalità. Nelle cronache di quella più recente in corso in Ucraina, l’attenzione ai morti civili è altissima. L’attenzione allo stupro come arma di guerra è invece assai limitata, quasi assente, pur avendone notizia e conoscenza. Siamo informati e sono state descritte molte altre forme di violenza terribile sui corpi dei bambini, compresi i neonati, e delle madri, per non parlare delle deportazioni e delle separazioni. Ciò che colpisce è sì la violenza nei confronti dei civili, ma nella generica dimensione maschile. Non si considera, nè si racconta allo stesso modo la violenza che si esercita sui corpi femminili, considerati appunto come corpi e non come persone. Non hanno dunque la stessa rilevanza e non generano la stessa considerazione, la stessa empatia. Quasi fosse un reato minore, una lesione inferiore, mentre noi sappiamo tutte benissimo che è una ferita più profonda di una coltellata perché comporta implicazioni sull’identità di sé, sulla natura di sé, difficilissime da curare, recuperare, risanare.
Sottolineo che le forme di violenza sono molto ben classificate in tutti gli aspetti della vita delle persone, ma quando ci si avvicina alla violenza contro le donne, la classificazione è assai meno precisa ed efficace. Ad esempio, non vengono considerati come violenza tutti gli elementi che riguardano la subordinazione, l’impossibilità o la difficoltà ad essere indipendenti ed autonome. Non sono nemmeno reputati come comportamenti repressivi verso una parte del genere umano ma considerati “normali”.
In questo periodo, per calarci nell’attualità, si discute con notevole leggerezza del quoziente familiare, senza renderci conto che nei fatti si sta esercitando un’ennesima forma di subordinazione, di violenza, perché tutto ciò che impedisce ad una donna di essere autonoma e libera nelle proprie scelte comporta una condizione di costrizione e di sopruso. Da una parte non si coglie il segno di questa proposta per quel che è, non la si legge in questi termini, dall’altra scompare l’idea che per le donne esista un’autonomia economica e il loro è lavoro gratuito. Si dissolvono tutte quelle categorie che costituiscono la forza della normazione del lavoro dipendente come del lavoro autonomo, presenti nel sistema contrattuale, diretta espressione del potere maschile.
Con una perfidia in più: quando si esaminano i dati e le statistiche sulla differenza tra salario maschile e salario femminile, c’è sempre qualche esperto pronto a spiegare che le donne non sanno contrattare per loro stesse mentre gli uomini contrattano meglio. Lettura sbagliata che attribuisce ai singoli la responsabilità di ciò che nella società attuale costituisce un comportamento collettivo e di massa e ha origine nella sua visione patriarcale. Non riconosce l’attività di cura come lavoro e come tale retribuito. Di conseguenza, si ritiene che l’insieme del lavoro femminile abbia un valore minore rispetto a quello maschile. “Opzione donna” è l’esempio perfetto di queste considerazioni. I contributi versati dalle donne valgono meno, si può ricalcolare la pensione con il sistema contributivo, nonché stabilire in quali casi viene erogata e in quali no. Pensiamo cosa si sarebbe detto e fatto se lo stesso orientamento fosse stato applicato sulle quote 100/102/103. Oltre al caso in sé, il sistema delle quote sottende comunque un criterio molto maschilista perché non tiene conto delle diverse carriere presenti nell’ambito dell’occupazione femminile.
La forma di violenza esercitata in questa fase, solo apparentemente diversa, sta nel tornare ad inserire un altro gradino nella scala per cui solo se si è donna e madre si ha diritto a qualche attenzione di tipo protettivo. Riproponendo così un messaggio per cui la donna ha il diritto di andare in pensione non in quanto lavoratrice che ha faticato per un certo numero di anni, ma in quanto madre. Così facendo, si stigmatizzano, oltre che discriminarle, tutte quelle donne che madri non sono. Dimenticando, aggiungo, che a volte non si è madri anche per l’impossibilità di procreare del proprio partner. Si manifesta qui una sorta di schizofrenia: il valore sociale della maternità in quanto tale non viene riconosciuto, ma si introduce in maniera surrettizia e deviata in casi come questo. C’è un tratto paternalistico da un lato, e utilitaristico dall’altro, mai però a favore del riconoscimento del valore delle donne.
Nei loro confronti persiste il meccanismo della colpevolizzazione, peraltro analogo al meccanismo di colpevolizzazione delle marginalità. Ne consegue l’idea che comunque le donne siano marginali. Il messaggio che passa è che la società non è delle donne, soggetto in qualche modo collaterale, che viene ammesso, oppure non ammesso, o ancora ammesso per gradi a seconda delle situazioni e delle diverse condizioni date. Il valore sociale della maternità non viene riconosciuto perché rompe la gerarchia e la gerarchia non può essere rotta.
La gerarchia non è neanche paternalista, ma proprio patriarcale. In più, in questo momento, pur se ancora sfumata nelle cronache e nelle affermazioni di questa destra oggi al governo del Paese, esiste una chiara volontà di ricostruire una dimensione di famiglia che ha in sé la gerarchia, la determina e ne impedisce il superamento verso modelli diversi. Così, il meccanismo per cui se si è madre si è considerata un poco di più, non è tanto per il fatto di avere un figlio, quanto perché in tal modo si riproduce il modello e l’idea di famiglia che si vuole affermare.
In un contesto dove il mondo per fortuna è andato avanti e una serie di modi di imporre la subalternità sono venuti meno, è tuttavia ripreso un processo – classico della società liberista ma in cui è scivolata anche tanta parte dell’emancipazionismo femminile delle sinistre dei Paesi ricchi – che possiamo sintetizzare così: è colpa della donna se non si hanno i ruoli che paritariamente bisognerebbe avere in taluni settori. Ragionamento figlio di un lungo filo rosso che riguarda in realtà l’emancipazionismo e il suo continuare ad immaginare per gli uomini delle carriere lineari, figlie dei loro studi e determinate dai loro obiettivi, mentre per le donne il problema della retribuzione e delle carriere invece non esiste perché non hanno studiato le cose giuste o fatto le scelte più opportune. E’ uno scivolamento assai pericoloso che si accompagna, in questa stagione, con il famoso argomento del merito, che per le donne diventa un doppio capestro.
Soprattutto, in una fase di impoverimento bisognerebbe piuttosto monitorare attentamente quale investimento le famiglie continuano a fare sugli studi delle ragazze e dei ragazzi. Già i dati della pandemia avevano indicato una ripresa dell’abbandono scolastico delle ragazze in quanto risultava essenziale che fossero loro a reggere la famiglia, vista l’assenza di servizi sociali ancor più ampia del solito. L’acutizzarsi delle difficoltà economiche produrrà lo stesso meccanismo. Già dai racconti sull’orientamento scolastico che ha la faccia di tutti i programmi Stem, si coglie una spinta nei confronti delle ragazze verso l’interruzione del percorso scolastico o l’indirizzo verso studi che non consentono l’accesso all’università. Penso si tratti di rivalse quasi istintive, non coscienti: siccome le ragazze all’università sono di più, vanno meglio, hanno più successo senza mai dichiararlo, si prova a fermarle prima. E, contemporaneamente, si fa un discorso pubblico che è colpevolizzante, quello appunto del “hai sbagliato tutto nella vita, non hai saputo orientarti, non hai scelto bene nelle cose fondamentali”. Senza mai misurarsi con un mondo nel quale tutti gli andamenti sono circolari e nulla vive in solitudine. Mai ci si misura con il fatto che ciascuno di noi potrebbe anche essere lo scienziato più bravo del mondo, ma se poi non è presente un adeguato sistema della cura tutto precipita in un grande buco nero. Proprio l’incapacità di lettura e il non partire dalle persone, con tutte le loro caratteristiche e diversità, determina storture su storture e da qui nasce il bisogno di soggetti da “minorizzare”, ovvero rendere inferiori e dipendenti.
Approfondire il rapporto tra le vecchie e nuove espressioni di culture patriarcali e le nuove e vecchie forme di dominio, sopraffazione, violenza, fino al femminicidio non è un’operazione facilissima. Intanto, secondo me, vecchio e nuovo continuano a mescolarsi e, come in ogni trasformazione non c’è nulla di davvero cancellato, sepolto. Certo, con la modernità si assiste ad un incremento degli strumenti attraverso cui si esercita la violenza, ma se penso alle forme di sopraffazione e brutalità contro le donne ci accorgiamo che non esistono differenze così clamorose.
La conoscenza di genere, il femminismo, anche nelle sue versioni più elementari, è uno straordinario messaggio perché afferma che può esserci un’altra strada. Il femminismo ha rappresentato un’idea vincente dell’alternativa, quella che la sinistra va cercando, senza trovarla, rispetto al modello neoliberista. Al di là della complessità del pensiero femminista, c’è una traduzione di quell’elaborazione che ha raggiunto e coinvolto moltissime donne: si può fare! Ovviamente, nelle più infinite gradazioni, perché il femminismo dei Paesi occidentali non è esattamente lo stesso dei paesi arabi, ma quell’idea che ci può essere una modalità alternativa al dominio maschile sulle donne è un pensiero trasversale nel mondo, e si può esprimere nelle forme più diverse. Penso alle grandi manifestazioni in India contro lo stupro e lo stupro collettivo, fenomeni molto presenti in una società solo apparentemente non violenta. O alle mobilitazioni delle donne curde del Rojava, un modello paritario di governo. Il pensiero femminista corrisponde ad una complessità di pensiero occidentale che tiene insieme modello sociale e forme di violenza e si articola in tante elaborazioni e prese di coscienza. Ma, è evidente che in tutte le forme di femminismo si afferma il senso dell’alternatività.
E’ esattamente questa possibilità di alternatività a determinare un conflitto che nell’idea femminista è un conflitto di relazione e come tale propone un avanzamento della mediazione possibile. Gli uomini sono molto più in difficoltà ad affrontare il conflitto come elemento della mediazione, piuttosto che come elemento di scontro, di separazione. Il principio della dimensione dell’avanzamento nella ricerca della mediazione risulta un perno anche del pensiero emancipatorio, ma nella cultura femminista esprime tutta la sua capacità di modello alternativo, non di solo miglioramento dell’esistente.
Spesso, in nome di una parità omologante, si è portati a negare che uomini e donne sono diversi, un elemento di differenza non tanto delle singole persone, ma nella dimensione collettiva del proprio modo di essere. La diversità non sta tanto nel concepire il dominio come metro di misura delle relazioni private e sociali, ma nel pensare a forme di relazione cooperativa tra le persone che parte dalla vita concreta e dal cosa voglia dire star meglio o star peggio. Sottolineo che questo, da un altro punto di vista, rappresenta una bella fregatura perché ha ricostruito un mondo segregato che non è più esclusivamente quello della famiglia ma quello della cura, come se questa fosse un parametro aggiuntivo e non una dimensione fondamentale del vivere collettivo.
Non trovo mai nessuno sostenere concretamente che il motore economico del mondo sia la cura. È la moneta, la finanza, il capitale: tutte realtà che però spariscono se si prova ad immaginare un mondo senza cura. Riconosciamo che nella modernità si è fatto un salto che ha migliorato la qualità di vita delle donne e sarebbe totalmente sbagliato non vedere i risultati. Nei fatti ha spostato il conflitto su un gradino più avanzato. Anche se permane ancora quello segnato dalla violenza, si deve ragionare non più esclusivamente sul conflitto nelle relazioni dirette legate all’integrità del proprio corpo, come pure alla libertà di scelta sulla maternità, bensì sul potere nella società. Potere inteso come dimensione di non segregazione e di libertà di scelta di far parte di un mondo o di un altro. In questo si evidenziano anche i limiti di un messaggio che seppure è riuscito a imporsi dal punto di vista della relazione individuale, del rispetto e del riconoscimento reciproco, si è molto meno affermato dal punto di vista delle grandi questioni economiche che regolano questo mondo.
Spesso dico che il femminismo si è in qualche modo fermato alla porta del ripensamento sul lavoro, sull’organizzazione del lavoro, sui suoi meccanismi intrinseci. Il femminismo ha magari ragionato di retribuzione del lavoro di cura e del lavoro domestico o del lavoro riproduttivo, come viene chiamato nel linguaggio sociologico, e dunque della necessità di riconoscerlo come attività di lavoro, senza però aver affrontato o espresso un messaggio forte e chiaro sulla struttura gerarchica dell’organizzazione del lavoro che determina quei ruoli. Se si ritiene che la società patriarcale vada messa in discussione nei suoi pilastri, va fatto altrettanto con l’organizzazione del lavoro intesa in senso mondiale, locale e interdipendente, perché è parte di quella gerarchia. Non è, come dire, autonoma o autoprodotta, ma tratto essenziale di quella gerarchia patriarcale del mondo che si è affermata in modo assoluto.
Credo, inoltre, che prima o poi sarà bene riflettere ed analizzare l’ossessiva affermazione circa la rimozione di qualsiasi forma di conflitto. È secondo me un convincimento difensivo, proprio sia del modello neoliberista che di quello patriarcale. Trovo grave che tutti o quasi abbiano sposato questa idea. E se non mi stupisce nel pensiero di destra, mi colpisce, e molto, che si manifesti nel mondo della sinistra, perché l’esistenza di un modello alternativo, che sia il pensiero socialista, comunista, progressista in generale, è sempre stato basata sul fatto che si doveva “confliggere” per ottenerlo.
Tutto ciò che in termini di avanzamento abbiamo conseguito come riconoscimento universale dei diritti è avvenuto attraverso il conflitto. Aver portato a similitudine guerra e conflitto rende complicata questa discussione. Nel linguaggio comune è avvenuta ormai una sovrapposizione tra questi due termini, non vera e non reale in natura, perché il conflitto è verbale, dialettico, pacifico e non comporta la sopraffazione, né determina l’uso delle armi. La sovrapposizione di queste due parole ha proprio cambiato il senso, il valore del conflitto escludendo la dimensione fondamentale, quella relazionale, cioè il rapporto tra le persone, individualmente o collettivamente, chiamato a produrre sia il mutamento che una nuova sintesi. La nostra stessa Carta costituzionale è frutto di un fortissimo scontro, acuto e palese, ma era un conflitto delle idee.
Aver espulso il conflitto dalla dinamica delle relazioni pubbliche ha abbassato la qualità della politica. Se si guarda all’impresa, intesa come entità intoccabile, che ha collaboratori e non più lavoratori dipendenti, non si fa altro che negare la sproporzione dei rapporti di potere al suo interno. Operazione esattamente analoga a quella sulla collocazione delle donne e la loro subordinazione. È come se si fosse introiettato il principio che le forme di subordinazione siano necessarie. Ed ecco che non si vede più qual è l’alternativa, non si riesce a disegnare quale sia l’orizzonte futuro.
Dall’obbligo del velo in Iran, ai talebani che negano l’istruzione alle ragazze afghane, ai governatori americani che impediscono il diritto all’aborto delle donne statunitensi, alle leggi polacche assistiamo ad un attacco, direi globale, all’autodeterminazione delle donne. L’autodeterminazione fa paura e viene contrastata. Può cambiare la modalità per ostacolarla: attraverso forme pacifiche o violente, in forme più subdole o più dirette. Ma alla fine si torna drammaticamente all’origine del problema. La lettura maschile della necessità di subordinare le donne avviene attraverso il controllo del loro corpo. L’iniziativa degli Stati americani contro l’interruzione di gravidanza è la evidente riaffermazione del potere decisionale degli uomini che impongono il loro controllo sul corpo delle donne. Ed è anche l’affermarsi dell’idea che quella riproduttiva sia l’unica funzione del genere femminile. Come in tutte le altre circostanze ricordate, si manifesta sempre il rifiuto dell’autodeterminazione, si esprime sempre la negazione delle donne come esseri pensanti ed autonomi.
Mentre il cambiamento dei livelli di istruzione è stato, in tutto il mondo, enorme ed in continua evoluzione, vietare l’accesso all’istruzione corrisponde allo stesso principio. È il tentativo di impedire alle donne di pensare perché devono restare “corpo a disposizione”, utili a fare il lavoro che serve agli uomini, proprio in termini di mantenimento degli uomini. L’esclusione dagli studi è una delle forme più antiche di discriminazione e, non a caso, si ricorda la prima donna che si iscrisse all’università, la prima donna che si è laureata, in pratica si ricorda la negazione alle donne delle “libere professioni”. È con la scuola dell’obbligo che si affermava, ma siamo già negli anni Sessanta, il diritto delle ragazze italiane di intraprendere un percorso di istruzione che permettesse loro di continuare a studiare.
Nella sostanza, il processo di evoluzione nel riconoscimento dell’autodeterminazione ha avuto elementi molto forti. Penso alla diffusione in primo luogo alla maternità come libera scelta e alla possibilità di interrompere la gravidanza. E’ importante che sia emerso il tema della parità salariale, la possibilità di far carriera, o di vivere sole, circostanza che non era prevista né scontata in tante comunità, e in alcune non lo è neppure oggi. Se si mettono insieme tutte queste considerazioni, appare evidente quale grande rivoluzione abbiano fatto le donne. Ma proprio mentre appaiono chiari gli importanti passi in avanti che si sono compiuti, risulta evidente che il cammino non è concluso. Ed appare altrettanto lampante come sia violenta la reazione perché insieme alle relazioni interpersonali si sono messe in crisi quelle sociali e quelle istituzionali.
Va approfondito questo nesso perché la reazione è molto violenta ma non sempre la si legge e la si comprende per quel che è. Nel pensiero comune, la stessa “colpevolizzazione” degli studi è in realtà la prosecuzione dell’idea secondo la quale le donne non possano avere in partenza gli stessi diritti e le stesse opportunità degli uomini. Tutta la teoria del merito rappresenta l’antitesi che si possano avere degli stessi diritti in partenza, perché i diritti sono dati dal tuo sesso, e, aggiungo, dal tuo censo. E’ pur sempre esistita una quota aristocratica, non nel senso nobiliare ma oligarchico del termine, di donne. Quella cupola che invece di sfondare il tetto di cristallo, ha costruito l’attico. E questo aspetto, purtroppo, è frutto della deviazione di una parte del femminismo occidentale. Ed è il meccanismo che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, e che lei rivendica: “Io ho costruito per me”.
In tutto questo ragionamento che attiene alla violenza, quella esplicita che attacca fisicamente il corpo di una donna, o quella legata ai meccanismi appena fin qui raccontati, c’è dunque un tema sottinteso. Quello della sottrazione di potere: per affermare la mia libertà, sottraggo un pezzo di potere a te. Accanto a questo, ne sono sempre più convinta, va dato rilievo anche ad un altro grande tema che si chiama libertà. Affermando che la libertà delle donne è metro di misura della democrazia, implico due grandi problemi. Uno, appunto, il potere. Che deve essere condiviso e non può essere esercitato solo dagli uomini, che invece è il loro grande desiderio, quello che difendono con ogni forma di abuso. Ma l’altro è la dimensione della libertà individuale e collettiva. Questo resta un grande nodo irrisolto. E l’eccesso della parola libertà da parte della destra costituisce un elemento di perenne, sistematica confusione. Un esempio: nell’ultima Legge di Bilancio si è assistito ad una surreale disputa tra la libertà dei commercianti e la libertà dei consumatori sull’utilizzo del Pos. Dibattito che non si riesce a fare con la stessa rilevanza su sanità pubblica e sanità privata. E io non dimentico, per restare in materia, che la prima grande opera di privatizzazione della sanità fatta dalla Lombardia di Formigoni avvenne in nome della libertà. Lo slogan che campeggiava, ormai un discreto numero di anni fa, era: “Devo poter scegliere di essere curato come fossi in un albergo a quattro stelle”. Che, come noto, non è una libertà per molti perché è un problema puramente economico e di disponibilità finanziaria. Stesso ragionamento si sviluppò a suo tempo su istruzione pubblica e privata per introdurre, non proprio in linea con la Costituzione, il finanziamento alle scuole private.
L’idea che si può o si deve essere più liberi in ragione del censo, del potere politico che si esprime, o del potere economico che si detiene, è un progressivo travisamento del concetto stesso di libertà. Dentro il modello di individualizzazione della libertà, gli altri non ci sono più. E i primi “altri” a scomparire sono le donne. Con loro i migranti e l’universo delle varie forme della cosiddetta diversità, tutto ciò che è stato descritto e costruito nella letteratura politica come minoritario. Da sempre, e non a caso, sulle donne c’è una lettura che le considera minoranza o minoritarie. Sono la maggioranza del mondo, ma continuano a essere lette e raccontate come inferiori in modo funzionale al fatto che la loro libertà e il loro potere devono restare diversi, e dunque fuori, altro da chi e da ciò che regola i meccanismi economici di comando e di potere. E affinché rimangano lontane, occorre continuare a considerarle una minoranza. La “minorizzazione”, in realtà, è la principale forma di violenza perché lo stesso essere considerate inferiori permette l’abuso. Da qui discende la centralità del potere. La società patriarcale e i singoli uomini tendono a mantenere e difendere il proprio potere e ogni forma di autodeterminazione ne sottrae loro una parte, una fetta.
Al contempo, essendo profondamente cambiato il concetto di libertà, tutto si complica. L’abbiamo toccato con mano con il Covid: libertà individuale e libertà collettiva, libertà di far del male agli altri oppure di proteggersi dagli altri. Ad un certo punto la discussione si è concentrata sulla libertà individuale, ovvero fino a che punto la libertà individuale potesse arrivare a mettere a rischio la salute altrui. L’assunto dell’“io sono forte e quindi dimostro la mia forza nei confronti di tutti gli altri” si basa perennemente su un preciso concetto di minorità: “posso fregarmene degli altri perché sono minori rispetto a me”.
Si tratta di una questione di potere, di identità di gruppo. Non sempre implica un aspetto di genere, ma produce di per sé una deriva negativa che si riscontra pienamente nel concetto di libertà economica. La filosofia del “privato è meglio” perché permette al cittadino di essere libero di scegliere rappresenta la negazione, ancora una volta, del fatto che la vera libertà è nel diritto universale, cioè nell’essere latore di un diritto in quanto persona. E fa il paio con l’assunto che non deve esistere una diversa idea del potere. Non si accetta una teoria di potere cooperativo, divisibile ed esercitabile collettivamente perché per accedere al comando occorre invece omologarsi, far venir meno i propri convincimenti, modificare i propri comportamenti, il proprio modo di essere differente.
L’attuale Presidente del consiglio corrisponde pienamente a questo modello, perché dentro l’omologazione c’è il primato della persona singola, mai l’espressione di una dimensione collettiva. Lo conferma la sua prima Legge di bilancio, semplicemente misogina. Perché solo questo si può dire di una serie di norme scritte nell’ultima manovra. Ogni volta che si sfiora in qualche modo un modello femminile, lo si fa discriminando le donne. In questo, purtroppo, constato una profonda debolezza del pensiero della sinistra, che non esprime alcun pensiero antipatriarcale, anzi. Tutto sommato, considera più rilevante la biografia della presidente donna, che non l’avanzamento delle condizioni collettive. Tant’è che, guardando a quel che accade, c’è chi sostiene che allo sfondamento da parte di alcune del tetto di cristallo, si è aggiunta la colla sul pavimento per tutte le altre.
Lo dico più direttamente possibile: se lo sfondamento del tetto di cristallo significa l’omologazione ai comportamenti maschili, la società non cambierà mai e dunque non mi interessa. A Palazzo Chigi si eserciterà un potere che non cambia nei modi di essere e sarà un potere autoassertivo, esattamente come quello maschile, che non permette alla società di avanzare perché non tollera, anzi nega l’esercizio del conflitto. E rifiuta il dubbio, la possibilità di cercare ed individuare soluzioni differenti da quelle che normalmente vengono realizzate. Perciò considero la manovra del 2022 una somma di discriminazioni nei confronti delle donne, di misure di carattere misogino, di ricette che vengono riproposte esattamente uguali a prima. E’ in tutto e per tutto una conferma, semmai ce ne fosse bisogno, della preservazione di quel modello di potere, senza alcuna idea di cambiamento, anzi, recuperando le parti più retrive della storia recente.
L’ultimo passaggio di queste nostre considerazioni si concentra sullo specifico punto di vista delle donne contro le guerre e le armi, contro l’odio, le discriminazioni affermando di converso la cultura del rispetto, del dialogo e della pace. Alla domanda su come si esprima la forza della rivoluzione femminile rispetto a un mondo che non ci piace, rispondo semplicemente dicendo in premessa che il femminismo è pacifista. In questo, richiamando una sintesi di una cultura femminile storica molto raccontata ed esemplificata nel “non voglio fare figli per la guerra”. La contrapposizione tra generativo e distruttivo esprime un sentimento che persiste e ha permeato il comportamento femminile. Ed è la contrapposizione tra la vita e la morte. Forse, una delle ragioni del grande odio maschile verso l’altro genere sta proprio nell’incapacità di generare la vita. Gli uomini si sono sempre ritagliati un ruolo di potere ma vivono la contraddizione di non far parte del processo generativo. In realtà, potrebbero esserne parte, e questo sarebbe davvero un grande cambiamento. Questo è il primo elemento: si nasce per vivere, non si nasce per morire.
Il conseguente argomento riguarda la necessità di relazione, perché tutto ciò che è generativo è in relazione, in rapporto con il figlio, con il padre del figlio o con il contesto più immediato. Ovviamente non è sufficiente, perché le donne sono in sé generatrici, ma non sono “necessariamente” generatrici. Non lo sono per ragioni fisico-biologiche o per ragioni di scelta, ma sono in ogni caso portatrici di cura e vivono comunque questa dimensione. Ci sono naturalmente anche delle eccezioni, come le donne guerriere, ma se la dimensione femminile è comunque quella dell’attenzione all’altro, agli altri, alle altre, ovvero il valore della cura, dello stare bene e star bene insieme, ebbene, in un modello di mondo del futuro non è prevista l’idea che si possa venire ammazzati, che possa arrivare un drone sulla propria testa, che possa venire distrutto un ospedale, una scuola, cioè tutto quanto fa parte di quel mondo che dà la vita e continua a permeare la vita.
Altra evidenza riguarda il femminismo inteso come la forza delle donne che nelle sue tante espressioni differenti mette in discussione i meccanismi di potere attuale. E anche questo confligge con la guerra. Non è forse la guerra lo strumento del potere finale e definitivo che afferma la sua potenza travolgendo l’altro, occupando territori, sottraendo risorse fondamentali? La dimensione, chiamiamola cooperativa, del potere che non ha bisogno di supremazia, non considera la guerra tra gli strumenti possibili.
Il femminismo è un modo di stare al mondo, una capacità nuova di lettura alternativa del vivere comune che si colloca nel versante, ancor più del pacifismo, della negazione della guerra come strumento possibile. La nostra Costituzione utilizza una locuzione fondamentale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Dunque, l’utilizzo della guerra non è nella possibilità dell’esercizio del potere del Paese. E, in stragrande maggioranza, le donne pensano che, a partire dalla cura che hanno del mondo, non è possibile l’utilizzo della guerra come strumento.
Ciò non vuol dire ovviamente che le donne sono disposte a farsi opprimere in tutti i modi. Le donne si mettono in gioco, lo dimostra la Resistenza, come già i moti risorgimentali, per parlare del nostro Paese. Oggi lo affermano soprattutto le ragazze iraniane che mettono i loro corpi e la loro vita a disposizione di quella lotta. O le ragazze del Myanmar che stanno vivendo situazioni analoghe, anche se di loro, come abbiamo detto, non sentiamo nemmeno parlare.
Sappiamo con certezza che il movimento delle donne è uno dei più grandi fattori di cambiamento del secolo scorso e anche di questo. Il ripudio della guerra non comporta solo l’indisponibilità a mettere il proprio corpo e il proprio agire in relazione con la violenza e la guerra. E’ il ritenere che esistano modalità diverse dall’uso delle armi e dello sterminio dagli altri per risolvere le controversie. Torna l’esercizio del conflitto che non è sinonimo di guerra. Se vogliamo un esempio lampante di questa possibilità, basta richiamarci ancora alla rivolta in Iran: è pacifica, non usa armi se non quelle dell’ironia, degli slogan, del mettere i loro corpi in piazza a cui si contrappone una reazione esclusivamente maschile, che spara, che ammazza, che impicca, che stupra. Una reazione che sceglie un’unica modalità: non l’esercizio di un conflitto relazionale e della costruzione di soluzioni, ma l’uso esclusivo della violenza. Il pensiero va, nello stesso tempo, alla grande affermazione paritaria della Repubblica curda. Quella straordinaria esperienza ed affermazione di parità è arrivata nel mezzo di un violentissimo conflitto armato con l’Isis e non c’è dubbio che le donne curde siano state delle straordinarie combattenti, e come loro sono state le donne Yazide. In quel caso, non hanno rinunciato all’utilizzo delle armi e al combattimento. Ma non è stata loro la scelta di attaccare, si trattava di rispondere ad un’aggressione. E quella delle donne combattenti è parte di un popolo che è stato sempre aggredito e brutalizzato. Va ricordato che nella storia dei curdi, come degli azeri, altrettanto tragica e dolorosa, la prima forma di oppressione di quei popoli consisteva nello stupro e il rapimento delle donne. Questo, forse, ha alimentato quell’unità e quella parità del popolo curdo, non così comune in altre popolazioni.
Parlando del confine tra diritto di resistenza e la guerra per la guerra, dobbiamo constatare che proprio quel limite non si è trovato nella guerra tra Russia ed Ucraina. E quel confine, secondo me, vede uomini e donne sempre su sponde diverse. Le donne non hanno il gusto della guerra. Così come tentano di difendersi da una violenza privata, così provano a difendersi da una violenza collettiva qual è quella dell’aggressione e dell’oppressione. Ma, se possono, scelgono una modalità pacifica come quella iraniana che arriva anche a negare le loro vite, arriva fino a mettere a disposizione le loro stesse esistenze.
Proviamo in conclusione a coniugare in forma laica, progressista, di sinistra, femminista, il motto francescano “pace e bene”. Il migliore modo di tradurre laicamente quel motto è: diritti universali ed economia della cura. C’è un diritto delle persone allo star bene che è traducibile nel fatto che la responsabilità politica, quindi anche la responsabilità istituzionale, si esplica esattamente nel far sì che le persone abbiano gli stessi diritti e quella struttura di diritto pubblico che gli permetta di soddisfare i bisogni primari.
La dimensione collettiva del diritto va in crisi nel momento in cui non è universale. Se ci limitiamo al nostro Paese, pensiamo al dibattito su autonomia differenziata e processi di regionalizzazione per constatare come i diritti divengano appunto differenti anziché impegnarsi per renderli universali. La dimensione collettiva va in crisi anche se gli altri Stati non raggiungono o praticano gli stessi diritti. Questa era in fondo la grande intuizione, la sincera aspirazione alla base delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti dell’uomo. Ed è quell’universalità dei diritti la prima opposizione al conflitto, sta in quel principio il rispetto, il dialogo, la cooperazione che insieme negano la guerra. Non certo per caso procedettero in contemporanea i processi che portarono da una parte alla costruzione delle organizzazioni sovranazionali e dall’altra all’approvazione della grande Carta dei diritti. In quel felice incontro si racchiude il valore dello “star bene” di cui parlavamo prima.
Il “pace e bene” esprime anche un elemento di incontro e confronto con gli altri nell’avere o meno le stesse possibilità, avere o non avere la stessa autonomia, avere o meno uguale autosufficienza e soddisfazione di vita. Che non vuol dire “siamo tutti uguali”, perché siamo tutti diversi. Rappresenta però l’aspirazione affinché nessuno debba vivere in una condizione di costrizione e a nessuno venga negato il diritto alla libertà e ai servizi connessi a quei diritti. E’ l’affermazione di una condizione in cui un lavoratore dipendente non sia schiavo. Ovvero, poter fare le ferie, avere la malattia retribuita, un orario di lavoro civile, una retribuzione che permetta di vivere dignitosamente. E star bene vuol dire che ogni bambina possa essere sicura, libera e autodeterminata perché ha garantito l’accesso all’asilo nido, all’università, al lavoro.
C’è, voglio sottolinearlo in conclusione, una fortissima connessione tra la parola bene e la parola pubblico. Come c’è una straordinaria relazione tra la parola bene e la parola politica. Se si perde, si smarrisce la sfera del pubblico, se la politica si consuma ed abbandona il campo, ecco allora determinarsi un mondo disuguale, che non garantisce a tutti e tutte gli stessi diritti. Un mondo che non è più in grado di dare risposte positive alle persone. Un mondo dove a farsi sentire saranno sempre più le voci delle armi, della violenza e delle guerre.
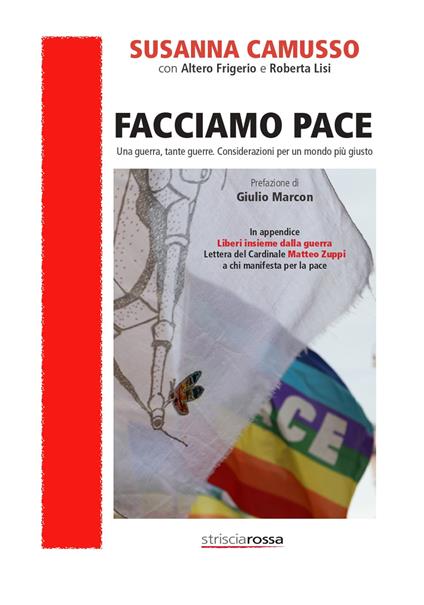
Il capitolo del libro “Facciamo Pace” è qui ri-editato per gentile concessione degli autori.




