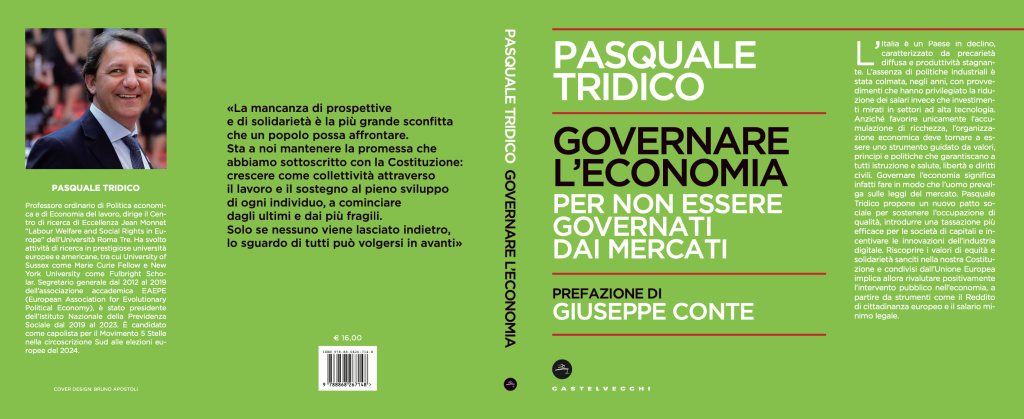Il ruolo della politica nei confronti dell’economia, il declino del Paese, il degrado del lavoro e la caduta dei salari, le possibilità di cambiamento sono al centro del nuovo libro di Pasquale Tridico, “Governare l’economia. Per non essere governati dai mercati” (Castelvecchi, 2024). Presentiamo un’anticipazione dall’introduzione al volume.
La nostra società e la nostra economia hanno bisogno di un rinnovamento. Spinte da un progresso tecnico e da un tasso di innovazione senza precedenti, le dinamiche economiche hanno trasformato velocemente le caratteristiche del mercato del lavoro e le sue forme, così come i processi produttivi. Non è cambiata però la governance che sottende questi processi, né dentro le aziende, né nelle istituzioni che li regolamentano. Si percepisce uno stallo nei progressi della qualità della vita, e in molti settori un peggioramento delle condizioni di lavoro, dei guadagni di produttività e quindi delle retribuzioni salariali. In Italia, se si considera il periodo tra il 1990 e il 2020, i salari medi sono diminuiti del 2,9%. In più, l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto dei lavoratori di circa il 15%.
Il 12% dei lavoratori è povero e il 30% a rischio di povertà, a causa di salari che non superano i mille euro al mese. Sembra che l’innovazione, invece che riduzione degli orari di lavoro, abbia comportato maggiore intensità, iper-connessione, stress da lavoro correlato. Innovazioni di processo e di prodotto, dentro e fuori le organizzazioni, sono accompagnate dall’introduzione massiccia di flessibilità e da assunzioni in forme precarie che nel 13% dei casi sono giornaliere e nel 38% hanno una durata inferiore a un mese. Precarietà e contratti brevi aggravano la condizione dei lavoratori poveri: nel 2022 vi erano 4,2 milioni di contratti a termine e 4,3 milioni di lavoratori che guadagnavano salari orari inferiori a 9 euro lordi. I dati sono estremamente negativi soprattutto per giovani e donne, in particolare per quanto riguarda le regioni meridionali del Paese (…).
In Italia l’orario di lavoro pari a 8 ore al giorno è stato fissato dal Regio Decreto n. 692 del 15 marzo 1923. Dopo di allora, solo l’introduzione del fine settimana in molti settori nel 1969-1970 ha comportato una riduzione dell’orario, ferme restando le otto ore giornaliere. Dobbiamo ambire a una settimana lavorativa più corta: oggi diverse analisi e ricerche effettuate laddove è stata adottata, come in Regno Unito e in Australia, dimostrano che nei servizi e nei settori a più alta intensità tecnologica aumentano la produttività e l’occupazione, oltre al benessere e all’efficienza dei lavoratori.
Non si può tollerare che il nostro sistema economico generi milioni di poveri e disoccupati e che allo stesso tempo enormi capacità produttive rimangano inutilizzate, con risparmi non mobilitati e investimenti non effettuati. Keynes raccomandava l’espansione del mercato, ma anche una gestione controllata della crescita, degli investimenti e della domanda aggregata al fine di raggiungere il pieno impiego. Non prevedeva di certo politiche di austerità e deflazione, come quelle attuate in risposta alla crisi finanziaria del 2008, né il crollo dei salari reali, nelle modalità verificatesi tra il 2022 e il 2023. Jean-Paul Fitoussi e Joseph Stiglitz hanno mostrato che le politiche di austerità implementate nel decennio scorso sono state fallimentari: è anche grazie al loro insegnamento che la recente pandemia è stata gestita correttamente dal punto di vista economico, senza ricorrere a politiche di austerity. In quest’ottica, si può affermare che negli ultimi trent’anni le uniche politiche che possono essere considerate puramente keynesiane siano quelle implementate durante i due Governi Conte, nel periodo che va dal 2018 al 2021. Queste politiche includono il Decreto Dignità, il Reddito di cittadinanza, il Superbonus edilizio, il sistema di protezione e sostegno al reddito universale messo in atto durante la pandemia, il blocco dei licenziamenti e la proposta di salario minimo (quest’ultima purtroppo non arrivata a compimento).
È necessario introdurre politiche che favoriscano la riduzione dei tempi di lavoro, la conciliazione tra famiglia e lavoro, la qualità dell’istruzione e della sanità pubblica. Occorre un massiccio investimento in innovazione e formazione delle competenze. Manca la consapevolezza di dover remunerare il lavoro di qualità, fornendo una strumentazione che consenta lo sviluppo di nuove capacità e quindi di maggiore produttività. Se si continua a fare competizione attraverso il costo del lavoro, anziché tramite l’innovazione, a rischio è la capacità di crescita dell’economia nazionale.
Una maggiore flessibilità non ha portato con sé maggiore occupazione o produttività, ma solo un aumento dei profitti. La flessibilità deve essere accompagnata da processi di formazione continua per il lavoratore, insieme alla sicurezza del reddito, alla qualità e alla stabilità di un impiego. Con il Jobs Act è stato svalutato il “posto fisso”, e oggi ci sorprendiamo che le persone ricerchino migliori condizioni e qualità di lavoro, smart working, tecnologie all’avanguardia, riduzione dell’orario, formazione: elementi che l’ossessione della flessibilità ha inevitabilmente peggiorato o combattuto. La maggioranza degli occupati non ritiene di dover mettere il lavoro al centro della propria vita, ovvero di dover seguire il mantra che ha attraversato tutto il Novecento del “guadagnarsi da vivere” attraverso il lavoro. Oggi i giovani vogliono innanzitutto avere una vita felice, e a questo fine si impegnano negli studi, nel volontariato, nella vita collettiva, nello sport. Pretendere una vita dedicata interamente al lavoro non risponde alle esigenze della società attuale.
Negli ultimi vent’anni, gli unici provvedimenti in direzione opposta alla flessibilità selvaggia sono stati realizzati con tre importanti decreti:
– il Decreto Dignità del luglio 2018, il quale ha frenato l’espansione del lavoro a termine con ottimi risultati, inserendo le causali per giustificare l’introduzione temporanea di lavoro, portando da 36 a 24 mesi il termine e limitando i rinnovi contrattuali. Il provvedimento è stato ripreso in Spagna, con la stessa logica;
– il decreto che ha introdotto il Reddito di cittadinanza (Rdc) nel gennaio 2019, che ha allentato la morsa della subordinazione cui erano sottoposti i lavoratori fragili. Il Rdc ha offerto un potere contrattuale maggiore a queste persone, che hanno potuto così rifiutare sfruttamento e salari da fame. In assenza di un salario minimo legale, il Rdc è servito quantomeno da “salario di riserva”; da soglia psicologica al di sotto della quale il lavoro non può considerarsi dignitoso. Rifiuto dello sfruttamento, perciò, piuttosto che rifiuto dell’etica del lavoro, come affermato da una parte della politica;
– il Decreto Riders del settembre 2019, che ha posto le basi per le prime tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, stabilendo la necessità di una loro maggiore regolamentazione; di maggiore chiarezza del vincolo contrattuale senza che debbano intervenire la magistratura o gli ispettori del lavoro; di condivisione e trasparenza degli algoritmi alla base del funzionamento delle piattaforme, che condizionano tempi di lavoro, scelte, consegne e attese, determinando rapporti professionali sostanzialmente a cottimo.
Stupisce che ci sia una parte di domanda di lavoro che non viene soddisfatta dall’offerta: molti posti di lavoro rimangono vacanti a fronte di elevati tassi di disoccupazione. I nostri giovani laureati migrano all’estero, attratti da più alti salari, migliori condizioni e tecnologie. Ignoriamo quello che sta succedendo negli altri Paesi avanzati dell’OCSE; mentre nel mondo si cercava di spiegare le condizioni che determinavano il fenomeno noto come “le grandi dimissioni”, in Italia abbiamo addossato tutti i mali del mercato del lavoro al Rdc, cui si imputava la scarsità di lavoratori, in particolare di quelli stagionali.
Il Rdc ha avuto invece non solo il grande ruolo di contenere la povertà, ridurre le disuguaglianze e contenere il lavoro nero, ma anche quello di evidenziare che in Italia c’è un grosso problema che si chiama “salari bassi” o “lavoro povero”. Il numero dei lavoratori stagionali non è mai stato così alto come nel 2022, più che raddoppiato rispetto al 2017, prima dell’introduzione del Rdc. Il numero dei lavoratori sprovvisti di regolare contratto ammontava nel 2018 a 3,4 milioni, mentre oggi è di 3,1 milioni. Anche l’evasione fiscale e contributiva è diminuita negli ultimi anni, da circa 130 a circa 100 miliardi di euro. Se non possiamo dire con certezza che il Rdc ha determinato queste riduzioni, possiamo però dire che in presenza del Rdc il lavoro nero non è aumentato (…).
Ci troviamo nel mezzo di una grande trasformazione, in cui l’intelligenza artificiale (IA) è sempre più realtà nei processi produttivi e plasmerà i nuovi modelli di lavoro. Un report del McKinsey Global Institute stima una distruzione di 400-800 milioni di posti di lavoro entro il 2030 a livello globale, e la creazione di altrettanti posti sulla base di politiche, formazione e investimenti adeguati. Una trasformazione che deve essere accompagnata da una rivisitazione delle politiche industriali e un reddito di cittadinanza sempre più universale e incondizionato. Sarebbe perciò utile cominciare a pensare, nell’Unione Europea, a un reddito di base legato alla formazione continua e alla riduzione degli orari di lavoro secondo il modello 100-80-100: 100% del salario, 80% dell’orario, 100% dei guadagni di produttività. Si tratta di un modello realizzabile perché i guadagni di produttività generati dall’introduzione dell’IA saranno talmente rilevanti da poter compensare la riduzione oraria.
Eppure, il Rapporto Censis 2023 dipinge l’Italia come un Paese in declino, in stato di sonnambulismo, con il 61% dei giovani che emigrerebbe se ne avesse la possibilità.Circa 82.000 persone si sono registrate all’AIRE (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) nell’ultimo anno: espatriati che non ritorneranno più, anche perché il governo Meloni ha rivisto al ribasso gli incentivi di riduzione fiscale per i rimpatri. Eppure, gli incentivi avevano in larghissima parte funzionato, con risultati apprezzabili nel 2020, con quasi 20.000 rimpatri, a fronte di un numero di espatriati diminuito a circa 23.000, da 30.000 che erano nel 2019. Il 46% dei giovani espatriati è in possesso di una laurea: un danno enorme all’accumulazione di capitale umano nel Paese e alla crescita della produttività. I nostri giovani hanno voglia di lavorare e rincorrono le aziende che offrono migliori condizioni e salari più alti, anche all’estero. (…).
L’Italia rimane inoltre uno dei pochissimi Paesi membri dell’Unione Europea senza un salario minimo legale, l’unico tra quelli del G7. Per il governo Meloni, la soluzione – basata su un recente rapporto molto controverso del CNEL – consiste nella contrattazione collettiva dei sindacati. La stessa che è notoriamente inefficace nei settori in cui si sono avute le maggiori perdite in termini salariali: la logistica, i servizi alla persona, i trasporti, il turismo.
Occorre, infine, sostenere i costi sociali della ineludibile transizione ambientale richiesta dall’UE, attuando efficacemente il PNRR e gli investimenti da esso previsti in questo settore al fine di alimentare la crescita del PIL, oggi purtroppo ritornata allo zero virgola (0,7% nel 2023 e nel 2024 in previsione), dopo due anni in cui le politiche espansive dei precedenti governi avevano permesso una crescita cumulata dell’11% tra il 2021 e il 2022.