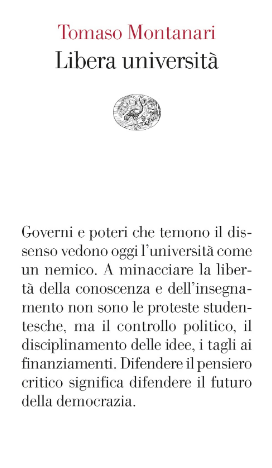“Libera università” (Einaudi) è il volume – in questi giorni in libreria – che Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha scritto sul ruolo dell’università e sugli attacchi a cui è sottoposta dai governi, in Italia e in altri paesi.
Tagli ai finanziamenti, disciplinamento delle idee, controllo politico sono le minacce di oggi, da parte di governi e poteri, alla libertà di conoscenza e insegnamento. In queste settimane si stanno diffondendo le proteste nelle università italiane contro riduzione delle risorse e precariato. Presentiamo qui un’anticipazione del volume, che offre una riflessione sul ruolo critico che l’università pubblica deve mantenere oggi.
Nella sintesi folgorante di Le Goff, le università del tardo Medioevo si ridussero a «centri di formazione professionale a servizio degli Stati». È un rischio sempre incombente, e non c’è dubbio che una parte cospicua del sistema universitario italiano di oggi veda se stesso proprio in quei termini, magari sostituendo a «Stati» la parola «imprese».
Nel 2021, la presidenza della Conferenza dei rettori delle università italiane (allora guidata da Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano) diffuse un ‘position paper’ che avrebbe dovuto esprimere una linea condivisa per una necessaria riforma del sistema universitario: un testo fortemente sbilanciato verso la funzione ‘professionalizzante’ delle università (e la versione originaria, poi emendata grazie al contributo di rettrici e rettori, e anche di chi scrive, lo era ancora di più). Ci si chiedeva retoricamente: «l’università è funzionale alle nuove esigenze della società? … Sarà in grado di rispondere alle necessità di un mercato del lavoro in continua evoluzione?», per auspicare quindi «un’università più dinamica e competitiva, in grado di adattarsi alle mutate condizioni della società» attraverso la creazione di «percorsi di studio più aderenti alle mutate esigenze del mondo del lavoro». Abbiamo detto quanto sia pericolosa ed esecrabile l’università feudale, introflessa e paga di sé, rappresentata dalle sontuose toghe prese in giro da Woolf, ma l’alternativa non può essere questa università ‘al servizio’ del mercato e del profitto: perché un’università ‘che serve’ rischia di essere un’università ‘serva’, quanto di più lontano dall’autonomia per la quale ogni generazione universitaria ha lottato, e continua a lottare.
Quando il primo comma dell’articolo 9 della Costituzione dice che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», stabilisce un nesso profondo tra cultura e ricerca, e delinea di fatto la vera ‘terza missione’ dell’università (terza dopo ricerca e didattica, e da loro procedente): quella appunto di alimentare e rinnovare la cultura. Si tocca qua un punto delicatissimo sia della vita interna dell’università, sia del suo rapporto con la società: e quel punto è appunto la sua relazione con la cultura, cioè la capacità dei suoi docenti di assolvere ad una funzione intellettuale. Detto nel modo più brutale: oggi moltissimi professori universitari (la maggior parte?) preferiscono pensare se stessi come ‘impiegati statali’ (cosa che non sono, nemmeno tecnicamente…), e non come liberi intellettuali critici. E bisogna dire che esattamente a questo serviva schiacciarli sotto un abnorme peso, sempre crescente, di pratiche burocratiche in buona misura non solo inutili, ma anche sadicamente vessatorie: a ridurli a passacarte senza il tempo, non dico di fare ricerca, ma nemmeno di pensare. Il risultato è almeno in parte stato raggiunto: e oggi moltissimi docenti universitari non credono di dover contribuire a cambiare il sistema (e, se necessario, a criticarlo pubblicamente, o addirittura a sabotarlo), ma invece di doverlo, appunto, servire. Come notavano le normaliste e i normalisti, «l’impegno civico è passato in secondo piano rispetto alla produzione scientifica. Perché l’impegno nel dibattito pubblico, lo schieramento aperto a favore o contro precise scelte politiche è considerato una macchia di cui l’accademico di oggi non deve sporcarsi?». La risposta sta proprio nell’idea di una università al servizio dello stato delle cose, un’idea antagonista e alternativa rispetto a quella che vuole l’università motore intellettuale del cambiamento. La necessità di compiacere i ‘portatori di interesse’ (un interesse quasi sempre inteso come ‘interesse economico’: nell’oblio del fatto che, per l’università, la portatrice di interessi è, in ultima analisi, la democrazia) e il disciplinamento conformante esercitato dalla valutazione fanno sì che oggi, paradossalmente, la capacità critica del singolo ricercatore sia messa a rischio proprio dal fatto di lavorare nell’università, cioè in «un sistema che premia il conformismo intellettuale e l’adesione volontaria a progetti richiesti non dalla scienza, ma dal governo, e dove la ricerca e il conferimento di titoli sono regolati di conseguenza, ossia in base alla necessità di conquistare e conservare una maggiore quota di mercato». Dalla fine degli anni ottanta del Novecento, si è constatato che gli intellettuali pubblici venivano sostituiti da una «fitta schiera di docenti universitari, inamidati e incapaci di esprimersi al di fuori del loro gergo, ai quali la società non presta alcuna attenzione». È quello che vuole, ovunque, il potere politico: una «intellighenzia, che comprende manager, docenti, giornalisti, esperti informatici o governativi, lobbisti, opinionisti e rubrichisti, consulenti pagati per esprimere un parere», attenta «al corretto stile di un vero professionista: non creare incidenti, non scostarsi dai modelli e dai limiti convenzionali, mostrarsi disponibili al mercato, e soprattutto mantenere il doveroso contegno: non prestando mai il fianco, non scendendo sul terreno della politica, mantenendosi ‘oggettivi’». Ciò che il sistema produce è, dunque, «un professionista supplice» (costretto, cioè, a supplicare per avere un posto non precario, e per ottenere i fondi di ricerca), mentre diviene rarissima, e d’altra parte intollerabile, la «figura solitaria, in certo modo distaccata, che a nessun costo si adegua alla società: un ribelle del tutto estraneo al modo di pensare omologato … un dilettante senza medaglie, coscienza critica del potere». Ma è invece proprio questa la famosa ‘terza missione’ dell’università: non la messa a profitto dei brevetti, ma (per usare le parole di Eco) «il rafforzamento e la difesa di valori fondativi universali, non ordinati negli scaffali di una biblioteca, ma diffusi e propagati con ogni mezzo possibile». Già, ma quanti professori universitari rammentano oggi che il loro dovere non si esaurisce affatto nelle aule e nelle biblioteche, ma appunto continua nel parlare ovunque, «con ogni mezzo possibile»?
Per questo non credo che la funzione dell’università sia rispondere alle esigenze attuali della società, o alle necessità contingenti del mercato, ma semmai fornire idee, strumenti, e teste ben fatte (e non ben piene…) per rinnovare, cambiare, articolare quelle esigenze sociali, e quelle necessità di mercato. Non modellare i corsi di studio su ciò che chiedono le imprese, ma immaginare le imprese del futuro: e su questa autonoma immaginazione costruire corsi di studio visionari; essere un laboratorio di idee, non un centro servizi; non una fabbrica di pezzi di ricambio per un mercato del lavoro autoreferenziale, ma un vivaio di intelligenze capaci di cambiarlo, quel lavoro ridotto a mercato: insomma, non essere al servizio del presente così com’è, ma essere un libero laboratorio di un mondo più avanzato, più libero, più sostenibile: più giusto.